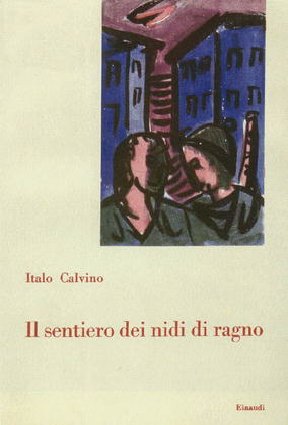
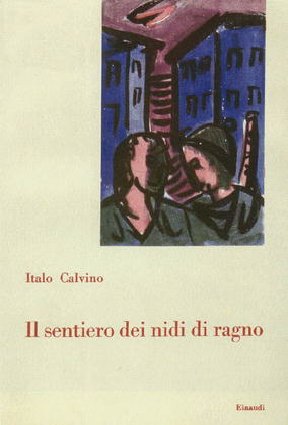
E’ questo il primo romanzo
di Italo Calvino, scritto nel 1946 e pubblicato
nel 47 . Nella prefazione che lo stesso Calvino scrisse all’edizione del
1964, così lo commenta:
“Questo romanzo è
il primo che ho scritto; quasi posso dire la prima cosa che ho scritto,
se si eccettuano pochi racconti(…) I segni dell’epoca letteraria si confondono
con la giovinezza dell’autore. L’esasperazione dei motivi della violenza
e del sesso finisce per apparire ingenua (…) Altrettanto ingenua e voluta
può apparire la smania di innestare la discussione ideologica nel
racconto (…)
Come entra questo libro
nella” letteratura della Resistenza”? Al tempo in cui l’ho scritto, creare
una “letteratura della Resistenza” era ancora un problema aperto, scrivere
il “romanzo della Resistenza” si poneva come un imperativo (…) A me, questa
responsabilità finiva per farmi sentire il tema come troppo impegnativo
e solenne per le mie forze. E allora, proprio per non lasciarmi mettere
in soggezione dal tema, decisi che l’avrei affrontato non di petto ma di
scorcio. Tutto doveva essere visto dagli occhi di un bambino, in un ambiente
di monelli e vagabondi. Inventai una storia che restasse ai margini della
guerra partigiana, ai suoi eroismi e sacrifici, ma nello stesso tempo ne
rendesse il colore, l’aspro sapore, il ritmo (…)
Posso definirlo un esempio
di letteratura impegnata, nel senso più ricco e pieno della parola
(…) Direi che volevo combattere contemporaneamente su due fronti, lanciare
una sfida ai detrattori della Resistenza e nello stesso tempo ai sacerdoti
d’una Resistenza agiografica ed edulcorata.
(…) Fu Pavese il primo
a parlare di tono fiabesco a mio proposito, e io, che fino ad allora non
me ne ero reso conto, da quel momento in poi lo seppi fin troppo, e cercai
di confermare la definizione.
(…) Quando cominciai
a sviluppare un racconto sul personaggio d’un ragazzetto partigiano che
avevo conosciuto nelle bande, non pensavo che m’avrebbe preso più
spazio degli altri. Perché si trasformò in un romanzo? Perché
- compresi poi – l’identificazione tra me e il protagonista era diventata
qualcosa di più complesso. Il rapporto tra il personaggio del bambino
Pin e la guerra partigiana corrispondeva simbolicamente al rapporto che
con la guerra partigiana m’ero trovato ad avere io.
(…) La memoria – o meglio
l’esperienza, che è la memoria più la ferita che ti ha lasciato,
più il cambiamento che ha portato in te e che ti ha fatto diverso
-, l’esperienza primo nutrimento anche dell’opera letteraria (ma non solo
di quella),ricchezza vera dello scrittore (ma non solo di lui), ecco che
appena ha dato forma ad un’opera letteraria insecchisce, si distrugge.
Lo scrittore si ritrova ad essere il più povero degli uomini. (…)
Un libro scritto non mi consolerà mai di quello che ho distrutto
scrivendolo: quell’esperienza che, custodita per gli anni della vita mi
sarebbe forse servita ascrivere l’ultimo libro, e non mi è bastata
che a scrivere il primo.
Italo Calvino, giugno
1964
Trama e commento
“Basta un grido di Pin,
un grido per incominciare una canzone, a naso all’aria sulla soglia della
bottega, o un grido cacciato prima che la mano di Pietromagno il ciabattino
gli sia scesa tra capo e collo per picchiarlo, perché dai davanzali
nasca un’eco di richiami e d’insulti (…) Ma già Pin è in
mezzo al carrugio, con le mani nella tasca della giacca troppo da uomo
per lui, che li guarda in faccia uno per uno senza ridere…”
Così è
presentato Pin all’inizio del romanzo. E’ un ragazzo, ma la vita, anzi
la malavita in cui è cresciuto, lo ha reso adulto anzitempo; conserva
però l’aria baldanzosa e scanzonata, propria della fanciullezza.
Fa da “ruffiano” alla sorella che esercita la prostituzione e, durante
l’occupazione tedesca, si presta a collaborare col nemico.
Pin fa il suo “lavoro”
con indifferenza e con cinismo, senza rimorsi; sembra uno scugnizzo napoletano
trapiantato in un paese della Liguria.
Mentre i romanzi sulla
Resistenza cominciano in genere con la presentazione di eroi “positivi”
impegnati a combattere il nazifascismo, Calvino inizia il suo romanzo presentando
un personaggio negativo, per di più tratto dall’ambiente della malavita,
parte di un’umanità che vive ai margini: antiborghese, antifascista,
antiliberale, antitutto insomma. Si tratta di un’umanità che sul
piano biologico potremmo definire animalesca, sul piano sociale, come appartenente
al sottoproletariato, e sul piano ideologico, anarchica, nel significato
più ampio del termine.
Ma è proprio così
degradata e così negativa questa umanità? Forse sì,
forse no. Forse è soltanto il volto dell’umanità “vera”,
prima che si affacciasse all’orizzonte la “linea” della “Storia”.
E la storia (con la s
minuscola) prende l’aspetto di una rivoltella nella fondina di un soldato
tedesco; si presenta subito con la violenza, o almeno con uno strumento
di violenza. Poteva essere un coltello di pietra o una mazza ricavata da
un ramo nodoso. Qui è una rivoltella, il progresso tecnologico ha
già mandato in frantumi il sogno di Rousseau di un “universo naturale”.
Ma Calvino conserva dentro di sé quella teoria, come un tesoro da
contrapporre alla cecità della catastrofe voluta dagli uomini.
Pin non è certamente
il “bon sauvage”, ma è indubitabile che è un “sauvage”, ed
è vicino alla natura idealizzata da Rousseau, anche se è
inserito nella Storia: ha dietro di sé secoli di miseria, di frustrazioni,
di desideri di riscatto inappagati. In ogni caso è al di qua di
quella che viene chiamata la "coscienza della situazione storica".
Tanto è vero che
ruba la pistola al tedesco, mentre costui è in commercio amoroso
con la sorella, senza sapere di preciso che cosa quel furto significhi.
Glielo hanno suggerito alcuni uomini all’osteria e lui ha eseguito, ma
più per provare il suo coraggio che per dare soddisfazione ai mandanti.
Una volta rubata la pistola, decide di tenersela. E’ un oggetto prezioso
per lui, l’arma lo esalta. Corre nel sentiero che lui solo conosce, osserva
i
nidi di ragno e nasconde la pistola sottoterra.
Lo schema della fiaba
è già presente, sia pure in forma molto sfumata, nell’”oggetto
favoloso”, cioè nell’arma che dà potere e potenza, come è
appunto nella tradizione delle fiabe, secondo Propp.
Anche i nomi dei personaggi
rimandano alle fiabe: Pin potrebbe essere il diminutivo di Pinocchio, poi
c’è Lupo Rosso, il Dritto, Giraffa, il commissario Kim (come il
protagonista dell’omonimo romanzo di Kipling) e infine il falchetto Babeuf
(Gracchus Babeuf, 1760-1797, fu il primo rivoluzionario sociale moderno.
Fece propria la causa del popolo lavoratore, teorizzando l'uguaglianza
universale: le idee gliele fornì la filosofia dell'Illuminismo,
le armi la rivoluzione).
Vediamo quindi che Babeuf
è un nome-simbolo dello spirito della guerra partigiana ed è
anche un segno della cultura del giovane Calvino, espressa con ironia allusiva.
Tornando alla trama del
romanzo schematizzata, Pin viene catturato dai tedeschi. In prigione conosce
il partigiano Lupo Rosso e insieme fuggono. Durante la fuga Pin perde di
vista il partigiano, vaga per i boschi finchè non incontra un uomo
della banda del Dritto. “Nel distaccamento del Dritto ci mandano le carogne,
i più scalcinati della brigata”.
Dritto è il contrario
del partigiano che ha una coscienza di classe: è un individualista,
”nelle azioni vuole sempre fare di testa sua e gli piace troppo comandare
e poco dare l’esempio” .
Inoltre si dichiara sempre
malato; ma è un uomo coraggioso e nella guerra partigiana non si
può fare a meno di nessuno.
Nella banda del Dritto,
Pin si trova come a casa sua, nel suo quartiere: gli uomini che incontra
sono come quelli di sempre; anche il personaggio chiamato Cugino, l’”odiatore
delle donne”, gli è in qualche modo familiare. Per Pin, la guerra
fatta così, in quella banda di derelitti, è un’avventura
come un’altra. E le cose che vi accadono, come l’amore del Dritto per la
moglie del cuoco e la vendetta di questi che appicca il fuoco all’accampamento,
non lo sorprendono più di tanto.
Questo tono avventuroso
si interrompe bruscamente quando, nel capitolo nono, arriva il commissario
Kim per indagare su chi ha provocato l’incendio.
Kim è uno studente,
”ha un desiderio enorme di logica, di sicurezza sulle cause e sugli effetti,
eppure la sua mente si affolla ad ogni istante d’interrogativi irrisolti”.
Non è aribtrario supporre che nel commissario Kim Calvino abbia
voluto rappresentare se stesso; ed è per questo che ad alcuni critici
questo capitolo è parso una stonatura stilistica, un’indebita intrusione
autobiografica. E’ invece l’episodio della presa di coscienza della guerra
partigiana, del suo significato.
La violenza e l’odio
esistono in entrambi i fronti, in quello partigiano e in quello fascista.
Ma Kim è certo di una cosa: lui e i suoi combattono per costruire
un’umanità senza più rabbia, “serena, in cui si possa non
essere cattivi”. Sono dalla parte della storia, del progresso: Negli altri,
i fascisti, l’odio, il furore e perfino gli “ideali” non sono biologicamente
molto diversi. Ma c’è una differenza decisiva: i fascisti combattono
per “perpetuare quel furore e quell’odio” per ribadire il loro sistema
mentale e politico fondato sul dominio brutale dell’uomo sull’uomo.
“Questo è il vero
significato della lotta” pensa Kim “il significato vero, totale,al di là
dei vari significati ufficiali”.
C’è un tono di
predica demagogica che non appartiene alla poetica e alla cultura di Calvino,
e soprattutto al mondo di Pin, per il quale il manicheismo si manifesta
in forma istintiva, non certo come problema politico. Quando si mette a
odiare il partigiano Pelle che è passato dalla parte dei fascisti,
il suo primo pensiero corre alla pistola nascosta, all’oggetto magico il
cui nascondiglio ha rivelato al traditore senz’accorgersene.
C’è una pagina
molto bella e commossa, quando Pin corre verso il sentiero dei nidi di
ragno e si accorge che quell’angolo di paradiso che aveva scoperto
e si era tenuto per sé, come l’unica cosa buona che gli fosse rimasta
al mondo, è stato devastato dal traditore Pelle, che nella sua affannosa
ricerca della pistola ha distrutto tutto.
Perduto il paradiso,
privo dell’oggetto magico, cosa farà adesso Pin? Piange “a testa
tra le mani. Nessuno gli ridarà più la sua pistola”.
Per la prima volta in
tutto il romanzo piange lacrime vere. E piange perché gli hanno
rubato una pistola, un’arma costruita per uccidere. Che senso ha questo
pianto? Per un ragazzo cresciuto tra il sottoproletariato, un’arma è
sì un giocattolo magico, ma anche l’unico amarissimo strumento di
un possibile riscatto, benché ancora una volta non ne abbia la minima
coscienza.
Pin poi ritrova la pistola
nella camera della sorella, la prostituta che è stata con il traditore.
Se ne impossessa e fugge, dopo aver insultatola sorella: ”Cagna! Spia!”
. La guerra partigiana ha dato a Pin un barlume di coscienza di classe,
che però subito si spegne quando ritorna sul sentiero dei nidi di
ragno a mostrare all’unico amico che gli sia rimasto, Cugino, il suo paradiso,
distrutto da quel fascista di Pelle.
Ed entrambi si augurano
che il regno si ricostruirà a poco a poco da sé, che la natura
tornerà a vincere sull’ira cieca e brutale degli uomini.
E’ notte, le lucciole
emettono le loro luci intermittenti. Sembrano meravigliose, ma per Pin,
viste da vicino, le lucciole “sono bestie schifose anche loro”. Calvino
chiude prendendole distanze sia dalla storia che dalla natura.