IL CINEMATOGRAFO
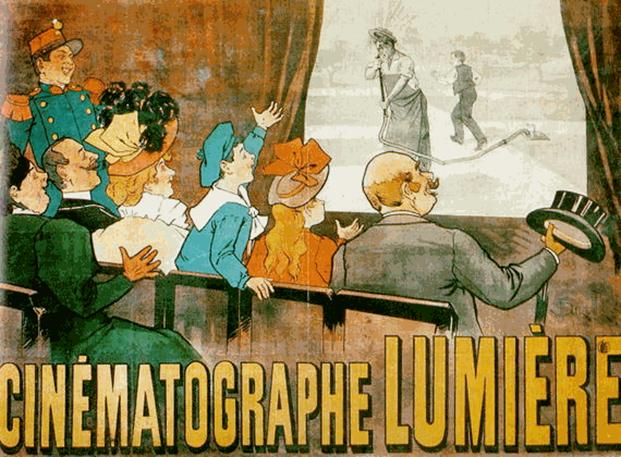
1876-1880 :
Émile Reynaud sviluppa il Praxinoscopio, il primo apparecchio al mondo capace di
proiettare delle immagini animate.
1885:
Apparizione delle pellicole flessibili a supporto in Celluloide. Senza queste
pellicole, il cinema non sarebbe stato possibile.
1890-1893:
Edison mette a punto la prima “camera” capace di registrare degli autentici films di cinema ; poi il primo “visore” che permetteva di osservare questi films.
1895:
I fratelli Lumière inventano il « cinematografo », primo apparecchio che permetteva non solamente riprese cinematografiche ma anche la proiezione di films.
1927:
Viene realizzato il primo film sonoro.
1936 :
Viene inventato il cinema a colori.

Il cinematografo è
una scoperta molto complessa ; suppone di avere
risolto cinque problemi :
1. - La formazione di una immagine fotografica su una
pellicola di celluloide
2. - La proiezione luminosa di immagini (come con le
lanterne magiche e le fantasmagorie di Robertson,
1798),
3. - L'analisi del movimento in immagini,
4. - La sua sintesi, e infine,
5. - La sincronizzazione di tutti questi fattori attraverso
un supporto, la pellicola bucata e mobile.
1. -
La fotografia si sviluppa nel XIX secolo dapprima su
lastra sensibile (la luce impressiona la materia chimica della lastra e lascia
un'impronta che sarà evidenziata chimicamente). I sali d'argento permettono un
miglioramento della sensibilità. Successivamente è
stata messa a punto attraverso la pellicola morbida che può arrotolarsi.


2.- La
proiezione luminosa ha bisogno di una sorgente luminosa e una lente per
rinviare su uno schermo una immagine ingrandida
dell'immagine di partenza. Le fantasmagorie di Robertson,
nel 1798 lo testimoniano.
Thaumatrope
3.- La
produzione del movimento che può farsi con una successione sufficientemente
rapida di immagini distinte ma poco differenti: a seguito della lentezza e
della persistenza delle sensazioni della retina (circa 1/3 di secondo),
l'occhio ha l'impressione di vedere uno spettacolo continuo - se vi sono 16
immagini al secondo.
 Numerosi tentativi portarono
così a differenti scoperte: l'illusione ottica con la rotazione rapida delle
immagini nel "thaumatrope" nel 1823 (i
disegni dell'uccello da un lato del cartone e della gabbia dall'altro lato
girano rapidamente grazie alla torsione del filo e fanno sì che l'uccello
sembra essere nella gabbia), il "phénakistiscope"
di Plateau (1833) e il "praxinoscope" di Reynaud (1877) autore di numerosi film di
animazione.
Numerosi tentativi portarono
così a differenti scoperte: l'illusione ottica con la rotazione rapida delle
immagini nel "thaumatrope" nel 1823 (i
disegni dell'uccello da un lato del cartone e della gabbia dall'altro lato
girano rapidamente grazie alla torsione del filo e fanno sì che l'uccello
sembra essere nella gabbia), il "phénakistiscope"
di Plateau (1833) e il "praxinoscope" di Reynaud (1877) autore di numerosi film di
animazione.
4.-
Analisi fotografica del movimento. Le prime invenzioni utilizzano successioni
di foto istantanee (Étienne Marey
con il suo "fucile fotografiche", 1882). Con le pellicole
fotografiche di celluloide, l'invenzione del film diventa possibile. Edison,
copia le bande di carta perforata di Reynaud e
registra nel 1890 le prime immagini fotografiche su pellicola perforata. Le
invenzioni si succedono (Marey, il cronofotografo).
(thaumatrope)
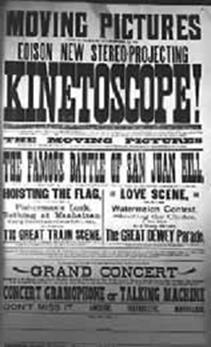

(phénakistiscope)

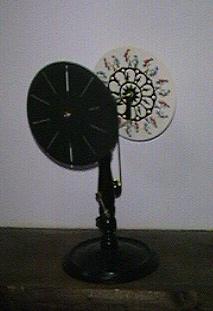 5. - Poi i fratelli Lumière inventano la pellicola forata e
il suo trattamento, portando una soluzione definitiva, pratica e semplice
all'insieme dei problemi. Essi inventano il sistema della pellicola perforata
che avanza di un passo sotto l'azione di una sorta di pedale (come nella macchina
da cucire): l'immagine è trascinata a scatto e si
ferma davanti all'obiettivo allora scoperto dall'otturatore. La luce lo traversa e proietta l'immagine sullo schermo, poi il
movimento ricomincia. A causa della rapida successione delle immagini e della
persistenza della retina, lo spettatore ha l'impressione di vedere uno
spettacolo in movimento proiettata sullo schermo. Il loro cinematografo è la
prima camera fabbricata industrialmente e che permette senza modificazione di
proiettare i film. Questa camera è reversibile, può servire alla ripresa o alla
proiezione su uno schermo; gioca di volta in volta il ruolo di camera o di
proiettore. La prima dimostrazione ha luogo il 28 dicembre 1895 a Parigi.
Questo film è muto. Ancora oggi le camere più perfezionate come gli apparecchi
per duplicare e per proiettare funzionano sul principio della camera dei
fratelli Lumière. Dopo la messa a punto della camera resta da
inventare la sonorizzazione del cinema.
.
5. - Poi i fratelli Lumière inventano la pellicola forata e
il suo trattamento, portando una soluzione definitiva, pratica e semplice
all'insieme dei problemi. Essi inventano il sistema della pellicola perforata
che avanza di un passo sotto l'azione di una sorta di pedale (come nella macchina
da cucire): l'immagine è trascinata a scatto e si
ferma davanti all'obiettivo allora scoperto dall'otturatore. La luce lo traversa e proietta l'immagine sullo schermo, poi il
movimento ricomincia. A causa della rapida successione delle immagini e della
persistenza della retina, lo spettatore ha l'impressione di vedere uno
spettacolo in movimento proiettata sullo schermo. Il loro cinematografo è la
prima camera fabbricata industrialmente e che permette senza modificazione di
proiettare i film. Questa camera è reversibile, può servire alla ripresa o alla
proiezione su uno schermo; gioca di volta in volta il ruolo di camera o di
proiettore. La prima dimostrazione ha luogo il 28 dicembre 1895 a Parigi.
Questo film è muto. Ancora oggi le camere più perfezionate come gli apparecchi
per duplicare e per proiettare funzionano sul principio della camera dei
fratelli Lumière. Dopo la messa a punto della camera resta da
inventare la sonorizzazione del cinema.
.
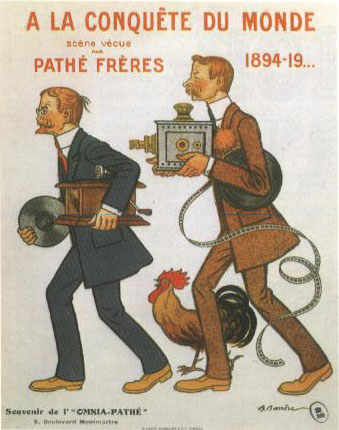
 Per convenzione si ritiene che il Cinematografo sia stato
inventato dai fratelli Louis e Auguste
Lumière nel 1895 a Parigi. In realtà anche altri come, l'inglese Robert William Paul, il francese Etienne Jules Marey, i tedeschi Max e Emil Skladanowsky e l'americano Thomas
Alva Edison, avevano sperimentato sistemi analoghi.
La scoperta si attribuisce ai Lumière perché sono
stati i primi a proporla ad un pubblico pagante il 28 dicembre 1895 (32
spettatori). Il primo film fu "L'uscita dalle fabbriche Lumière"
del 1895, appunto. Il cinema dei Lumière però si
limitava alla sola rappresentazione documentaristica della realtà. È con Georges Méliès,
illusionista e prestigiatore francese, che il cinema nasce come spettacolo di
finzione; introdusse per primo, il teatro di posa, l'illuminazione e la regia:
girò infatti per la prima volta film dove le sequenze
si susseguivano l'una all'altra come diversi quadri di una rappresentazione
teatrale; usò quindi per la prima volta un sia pur rudimentale montaggio, teso
soltanto al collegamento meccanico dei diversi rulli. Ricordiamo della sua
opera, in gran parte andata
Per convenzione si ritiene che il Cinematografo sia stato
inventato dai fratelli Louis e Auguste
Lumière nel 1895 a Parigi. In realtà anche altri come, l'inglese Robert William Paul, il francese Etienne Jules Marey, i tedeschi Max e Emil Skladanowsky e l'americano Thomas
Alva Edison, avevano sperimentato sistemi analoghi.
La scoperta si attribuisce ai Lumière perché sono
stati i primi a proporla ad un pubblico pagante il 28 dicembre 1895 (32
spettatori). Il primo film fu "L'uscita dalle fabbriche Lumière"
del 1895, appunto. Il cinema dei Lumière però si
limitava alla sola rappresentazione documentaristica della realtà. È con Georges Méliès,
illusionista e prestigiatore francese, che il cinema nasce come spettacolo di
finzione; introdusse per primo, il teatro di posa, l'illuminazione e la regia:
girò infatti per la prima volta film dove le sequenze
si susseguivano l'una all'altra come diversi quadri di una rappresentazione
teatrale; usò quindi per la prima volta un sia pur rudimentale montaggio, teso
soltanto al collegamento meccanico dei diversi rulli. Ricordiamo della sua
opera, in gran parte andata  persa, "Il viaggio nella luna" del 1902,
una sola famosa immagine patrimonio della memoria collettiva: un'astronave a
forma di proiettile conficcata nell'occhio della luna. È all'americano Edwin Stanton Porter che si deve la prima forma di montaggio
quale linguaggio cinematografico; la sua opera più
conosciuta è "L'assalto al treno" del 1903, considerato anche
il primo successo.
persa, "Il viaggio nella luna" del 1902,
una sola famosa immagine patrimonio della memoria collettiva: un'astronave a
forma di proiettile conficcata nell'occhio della luna. È all'americano Edwin Stanton Porter che si deve la prima forma di montaggio
quale linguaggio cinematografico; la sua opera più
conosciuta è "L'assalto al treno" del 1903, considerato anche
il primo successo.
Nel 1914 con "Cabiria"
di Giovanni Pastrone, ma già con "Quo Vadis?" del '13 di Enrico
Guazzoni, gli italiani inventarono il kolossal
dalle grandiose scenografie e faraoniche messe in scena. Dopo il 1914 si impose prepotentemente la genialità dell'americano David
Wark Griffith
che per primo costruì le fondamenta del linguaggio cinematografico capace di
discostarsi dall'eccessiva teatralità di cui soffriva il cinema: nacque così la
settima arte. Griffith intuì e ne mise in pratica tutti gli elementi basilari: montaggio delle
singole immagini, primo piano, piano americano, montaggio alternato,
dissolvenza e flashback, l'uso di più cineprese contemporaneamente, il
movimento delle stesse per seguire l'azione e non per ultima una complessa
ricerca sulla luce; "Nascita di una nazione",
1914, "Intolerance", 1916, "Giglio
infranto", 1919, "Agonia sui ghiacci", 1920.
In Europa nel frattempo
prende vita un cinema d'avanguardia che sfocia in due correnti principali, l'impressionismo
francese e l'espressionismo tedesco. All'impressionismo, che metteva in
primo piano la fotogenia, la bellezza pittorica delle immagini e l'indagine
psicologica, facevano capo Louis
Delluc, "Febbre", 1921, Marcel L'Herbier, "Eldorado",
1922, Jean Epstain,
"Il manifesto", 1925, Abel
Gance, "Napoleone", 1927, e più
tardi René Clair,"Entr'acte", 1924 e Jean
Renoir, "La grande illusione",
1937. All'espressionismo, che descriveva la realtà con una visione fortemente distorta e cupa del mondo, appartenevano
soprattutto Robert Wiene
e il suo "Il gabinetto del dottor Caligari"
del 1919, Friedrich Wilhelm
Murnau, con "Nosferatu
il vampiro", 1922, George Wilhelm Pabst, "Il
tesoro", 1923, e Fritz Lang, "Metropolis"
del 1926.
Non
da meno, ma successivo al 1925, l'importante movimento del formalismo
sovietico. Per i russi
le singole inquadrature non avevano vita e significato proprie ma le
assumevano solo in virtù di un montaggio espressivo. Questa è stata
un'intuizione fondamentale per l'evoluzione del linguaggio cinematografico in quanto arte; le singole inquadrature rappresentano le
lettere di uno scritto che si compie solo per mezzo del montaggio e un diverso
montaggio delle stesse inquadrature esprime un significato diverso. È doveroso
ricordare i primi teorici del cinema: Lev
V. Kulesov, "Dura lex",
1926, Dziga Vertov,"L'uomo con la macchina da presa", 1929, Sergej M. Ejzenstejn,
"La corazzata Potëmkin", 1925, che
per la stupefacente forza espressiva delle immagini e il rigoroso montaggio, è
considerato uno dei film cardine della storia del cinematografo; ma ancora
ricordiamo il grande apporto di Vsevolod I.
Pudovkin, "La madre", 1926, e Aleksandr Dovzenko,
"L'arsenale", 1929.
Menzione a parte per il
danese Carl Theodor
Dreyer e il suo realismo d'atmosfera che
scaturì dalle riflessioni sul lavoro delle avanguardie europee; l'opera di Dreyer, ricca di primi piani e di particolari, è realizzata
con elaborate tecniche di regia; ricordiamo soprattutto "La passione di
Giovanna D'Arco" del 1927-28 e "Il vampiro", 1931.Un'altra
corrente importante fu il surrealismo di quel trasgressivo narratore di ossessioni che è stato lo spagnolo Luis Buñuel, "Un chien
andalou", 1928; la sua carriera, tutta
controcorrente, ha profondamente influenzato il corso della storia del cinema.
In America contemporaneamente al genio melodrammatico e tecnico di Griffith si impose soprattutto il
cinema comico di Harold Lloyd,
Buster Keaton
e Charlie Chaplin. Quest'ultimo,
che nel 1925, con "La febbre dell'oro" fu autore di una opera d'arte, nel 1920 aveva comunque già girato lo
straordinario "Il monello".
L'avvento del sonoro,
inaugurato nel 1927 con "Il cantante di Jazz" di Alan Crosland, portò ad un impoverimento iniziale del
linguaggio, dovuto all'euforia per la nuova scoperta e all'audio di presa
diretta che irrigidiva gli attori in precisi schemi; ma poi seguì una ripresa
soprattutto grazie al solito cinema americano; cominciò così, e si spinse fino
agli anni cinquanta, il periodo del cosiddetto cinema classico americano,
caratterizzato dalla trasparenza della messa in scena e dalla mitizzazione dei
personaggi, tutto a vantaggio della comprensibilità; filosofia produttiva
premiata dal grande pubblico che ha contribuito ad elevare il cinema ad arte...
popolare.