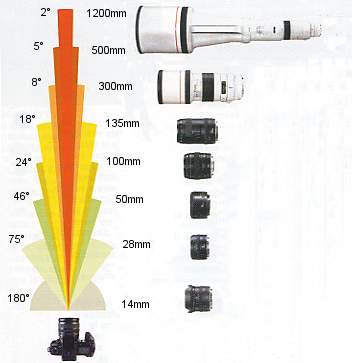LA MACCHINA FOTOGRAFICA

La Macchina
Fotografica
Volendo dare una definizione veramente semplice di "macchina
fotografica" o "fotocamera" potremmo
affermare che questa è essenzialmente una scatola dotata di un’apertura
circolare, attraverso la quale un sistema di lenti (l’obiettivo) proietta le
immagini su di una superficie sensibile alla luce (la pellicola), posta
all'interno della scatola stessa.
Questa
definizione Si avvicina molto alla descrizione di una delle prime macchine
fotografie. Una rudimentale macchina fotografica può essere costruita Con una
normalissima scatola da scarpe. Praticando un forellino al centro di uno dei
suoi lati, Si permetterà alla luce di entrare proiettando sulla parete interna
della scatola un'immagine capovolta od invertita della scena antistante.Per restituire un'immagine dai contorni
netti, queste rudimentali macchine hanno bisogno di un foro molto
piccolo (chiamato "foro stenopeico").
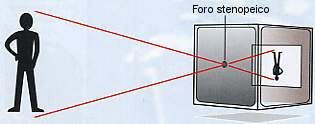
Ma un
foro di piccolissime dimensioni non permette di far entrare molta luce e
quindi, per impressionare una pellicola posta all'interno, è necessario esporla
per lungo tempo ai raggi luminosi. Se però si aggiunge
un obiettivo, sarà possibile far entrare molta più luce, riducendo cosi il
tempo d’esposizione.
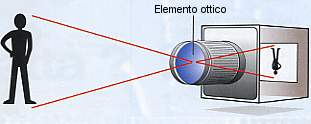
Come
vedremo meglio in seguito la pellicola ha la capacità
di fissare le immagini grazie ad una sostanza sensibile alla luce che la
riveste.Le comuni pellicole sono costituite da nastri
in materiale plastico avvolti in un cilindro metallico a tenuta di luce,
chiamato “rullino”. Naturalmente le attuali fotocamere
sono dotate di sistemi complessi e sofisticati che
consentono di ottenere ottimi risultati anche senza possedere particolari
conoscenze teoriche.Sul mercato vi sono
sostanzialmente due tipi di macchine fotografiche: Reflex con obiettivi
intercambiabili e compatte con obiettivo fisso.
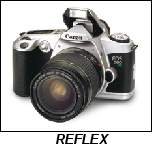

Le
Compatte sono macchine economiche, semplici e pratiche da utilizzare, ma
rispetto alle Reflex presentano numerose limitazioni
che vedremo in seguito nello svolgimento del corso.Le
macchine di tipo Reflex ci permettono di ottenere risultati migliori grazie ai
vari sistemi di regolazioni e ad una vasta gamma d’accessori.Una
macchina fotografica molto sofisticata e costosa però
non garantisce la buona riuscita di una foto, è anche necessario, infatti,
apprendere alcune nozioni che permettano di affrontare senza incertezze ogni
situazione.
Cos’è un obiettivo
L’obiettivo
è uno degli elementi fondamentali che costituiscono la macchina fotografica
Si tratta di un dispositivo ottico posto sulla parte frontale
della fotocamera, all’interno del quale sono
alloggiate diverse lenti ed il diaframma. Gli obiettivi delle moderne fotocamere sono dotati di speciali contatti elettrici che
permettono di regolare l’apertura del diaframma e la messa a fuoco direttamente
dalla fotocamera stessa. II compito fondamentale
dell’obiettivo è quello di raccogliere i raggi luminosi che costituiscono l’immagine,
o proiettarli sul piano della pellicola. Per una legge dell’ottica le immagini vengono riportate sulla pellicola capovolte e rovesciate
rispetto alla realtà.
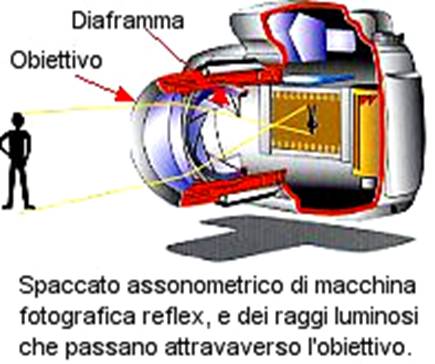
Teoricamente un obiettivo potrebbe essere costituito da un’unica
lente (le prime fotocamere erano
infatti caratterizzate da un obiettivo con una sola lente), ma in
pratica gli attuali obiettivi sono dei complessi gruppi di lenti, di diversa
forma o dimensione, atti a riprodurre un’immagine il più fedelmente possibile.
La presenza di molte lenti serve a correggere quegli errori (detti aberrazioni
ottiche) che altrimenti un’unica lente determinerebbe.

Nelle fotocamere Reflex l’obiettivo può essere facilmente tolto e
sostituito, a seconda delle esigenze, con altri dalle
caratteristiche differenti.
La lunghezza focale
Le macchine
di tipo reflex dispongono della possibilità di
intercambiare gli obiettivi; questa particolarità ci permette di ottenere
svariati risultati a seconda delle esigenze e del nostro gusto.
Esistono obiettivi particolarmente indicati per le fotografie
panoramiche o di interni ed altri invece utili per le
riprese da lunga distanza i quali, proprio come un cannocchiale, producono un
notevole ingrandimento del soggetto.

Queste diverse caratteristiche sono determinate dalla differente
lunghezza focale con cui può essere costruito un obiettivo. La lunghezza focale
è definita come la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo ed il piano
focale; in pratica, per un obiettivo elementare costituito di una sola lente, è
la distanza alla quale deve essere posta la lente, rispetto al piano della
pellicola, affinché l'immagine di un oggetto posto ad infinito risulti perfettamente nitida su di essa. La lunghezza focale
è espressa in mm e viene sempre indicata sul corpo
dell'obiettivo.
La lunghezza focale è estremamente
importante perché influisce sul rapporto di riproduzione e quindi
sull'ingrandimento relativo di un'immagine. Possiamo notare che le dimensioni
di un soggetto visto attraverso un obiettivo da 50 mm sono
grosso modo uguali a quelle del soggetto visto ad occhio nudo. Diversamente
utilizzando obiettivi con focale inferiore ai 50 mm si avrà invece un
rimpicciolimento delle dimensioni del soggetto. Viceversa con obiettivi
superiori ai 50 mm si avrà un ingrandimento delle dimensioni del soggetto, in
misura sempre maggiore man mano che la lunghezza focale aumenta. Si può quindi
dire che le dimensioni di un soggetto riprodotto utilizzando un obiettivo da
50mm, saranno il doppio di quelle ottenute con un
obiettivo da 25mm e la metà dì quelle ottenute con un obiettivo 100mm. La lunghezza focale oltre ad influire sull'ingrandimento relativo
di un'immagine determina anche la porzione di spazio inquadrabile da un
obiettivo. Questa porzione di spazio è definita dall'angolo di campo ed
è inversamente proporzionale alla lunghezza focale dell'obiettivo: in pratica,
maggiore è la lunghezza focale e minore è l'angolo di campo inquadrato (ad
esempio un obiettivo da 100 mm ha un angolo di campo di 24°); viceversa per
inquadrare vaste porzioni di spazio è necessario impiegare obiettivi dalla
corta focale, che hanno un notevole angolo di campo
(ad esempio un 24 mm ha un angolo di campo di 84°).
Detto questo, risulta facile comprendere
come l'ingrandimento relativo e l'angolo di campo siano in stretta
relazione tra loro: infatti, per riprodurre nello stesso fotogramma una
maggiore porzione di spazio e quindi un maggior numero d'elementi presenti
nella scena, le dimensioni di questi ultimi dovranno necessariamente ridursi.
In base alla
lunghezza focale si possono distinguere tre grandi categorie d'obiettivi:
|
Obiettivi grandangolari (35 mm o minori ): per grandangolare si intende
quell'obiettivo con una lunghezza focale inferiore
ai 50mm. Il nome stesso ci da già un'idea della sua funzione e cioè di consentire inquadrature con un ampio angolo di
campo. Un'altra caratteristica importante di questa categoria di obiettivi è la notevole profondità di campo, che ci
consente di vedere a fuoco quasi tutta la scena inquadrata, dal soggetto
molto vicino fino a quello più distante. |
|
|
Al diminuire della lunghezza focale,
infatti, corrisponde un aumento della profondità di campo. Con il
grandangolare è possibile riprendere un gran numero di elementi
restituendo immagini altamente suggestive e di grande profondità spaziale. In
genere questa focale si presta benissimo per la foto paesaggistica ed è
sconsigliato per il ritratto o meglio per il ritratto in primo piano in cui
si rende necessaria una distanza di ripresa ravvicinata, che con un tale
obiettivo comporta una distorsione prospettica del soggetto. Obiettivi normali (50 mm): questo obiettivo può essere
considerato la misura standard degli obiettivi, infatti guardando attraverso
di esso abbiamo la visione più simile a quella dell'occhio umano, cosicché le
immagini vengono riprodotte praticamente senza deformazione e le loro
proporzioni non |
|
|
vengono stravolte. Quest'obiettivo
è poco ingombrante e molto versatile, in quanto può
essere utilizzato per fare vari tipi di foto, da quella paesaggistica a
quella del ritratto. In genere questa focale viene
fornita assieme al corpo macchina della fotocamera
al momento dell'acquisto. I teleobiettivi (85 mm o maggiori): possiamo
considerare teleobiettivi quegli obiettivi che presentano una focale che va
da circa gli 85 mm in su. I teleobiettivi a differenza dei grandangolari
riprendono entro un ristrettissimo angolo di campo, il quale si riduce
all'aumentare della lunghezza focale, ma permettono di inquadrare soggetti
che si trovano a grande distanza ingrandendone le
dimensioni sul fotogramma. Diversamente dai grandangolari le lunghe focali determinano una notevole riduzione della profondità di campo, e
di conseguenza la messa a fuoco dovrà essere accuratamente regolata. |
|
L'esposizione alla luce
Ora è
arrivato il momento di spiegare un elemento che è determinante
per la realizzazione di una buona fotografia: questo elemento è la luce, o
meglio la luminosità dell’immagine.
Non a caso Ia parola “fotografia”, deriva dall’unione di due
parole greche: phos = Luce e grafein
= scrivere; “scrivere o disegnare con la luce”.Cosi come il nostro occhio, Ia macchina fotografica è il
mezzo che ci consente di catturare le immagini della realtà. Tutte le cose che
vediamo nella realtà circostante vengono percepite dai
nostri occhi grazie alla luce. Allo stesso modo la luce, naturale o
artificiale, è un elemento indispensabile per fotografare. L’illuminazione va
quindi attentamente calibrata e dosata per ottenere un’immagine ben riuscita,
ma va anche opportunamente scelta in funzione del carattere emozionale che una
trasmette. La macchina fotografica ci permette di controllare per mezzo di
sistemi di regolazione interni, la quantità di luce che
arriva alla pellicola ottenendo cosi risultati.I
meccanismi principali che determinano la quantità di luce che arriva alla
pellicola sono: il diaframma e l’otturatore.
II diaframma
Nelle macchine reflex la luce raggiunge la pellicola passando attraverso
un foro posto all’interno dell’obiettivo; la dimensione di questo foro può essere
variata tramite un dispositivo chiamato
Diaframma. Maggiore è la dimensione del foro, maggiore è la quantità di luce
che giunge alla pellicola. Viceversa, se il foro viene
ristretto la luce che penetra all’interno della macchina sarà minore.
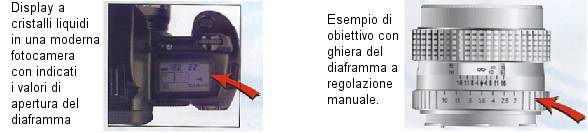
II
diaframma nelle macchine Reflex generalmente viene
impostato per mezzo di una corona di regolazione (ghiera) che si trova
sull’obiettivo. Attualmente però vi sono sempre più
macchine che adottano sistemi di regolazione elettronica, sulle quali basta
impostare il valore sul display premendo appositi tasti. Per quanta riguarda le
Compatte ricordiamo invece che questo tipo di regolazione spesso non o presente.Sui sistemi di regolazione del diaframma troviamo sempre dei numeri che servono ad indicare l’apertura del diaframma
stesso. Leggendo questi valori dobbiamo prestare particolare attenzione a non
farci ingannare dai numeri, poiché chi non ha esperienza potrebbe pensare
istintivamente che ad un numero piccolo corrisponda un’apertura piccola e, ad
uno grande un’apertura grande. Questo non è vero, anzi è vero il contrario, cioè che maggiore è il numero, minore è l’apertura del
diaframma; viceversa, ad un numero piccolo corrispondo un’apertura maggiore! II
motivo di questa corrispondenza inversa è dovuto al
fatto che il numero indicato è il denominatore di un numero frazionario, ad
esempio 1/5.6 o 1/22.Bisogna fare presente che il
valore d’apertura del diaframma 6è generalmente indicato con la lettera “f”
seguita dal numero corrispondente all’apertura. Avremo quindi per esempio f/1,
f/1.4, f/2... fino a f/22 e più, dove f/1 corrisponde ad un’apertura grande
mentre f/22 ad una molto piccola.

L’otturatore
Abbiamo detto
che il diaframma determina la quantità di luce che entra nella macchina. Un
altro dispositivo che insieme al diaframma agisce sulla quantità di luce è l’otturatore.

Esso
è una sorta di tendina posta tra il diaframma e Ia pellicola, che aprendosi
permette il passaggio della luce per un determinato tempo: maggiore è il tempo di apertura, maggiore sarà l'esposizione alla luce.Questo avviene ogni qualvolta scattiamo
una fotografia. Nelle macchine Reflex il tempo di apertura
dell’otturatore può essere regolato tramite un’apposita ghiera che riporta
indicati i tempi di apertura; nelle macchine attuali troviamo anche sistemi di
regolazioni digitali con indicazione del tempo impostato che appare sullo
schermo a cristalli liquidi (display); I tempi di apertura dell’otturatore sono
sempre indicati in secondi o in frazioni di secondo si va quindi da aperture di
alcuni secondi fino ad aperture di millesimi di secondo (Ia gamma di aperture
disponibili varia a seconda del tipo di macchina fotografica).
La coppia tempo/diaframma
Dopo aver analizzato singolarmente il funzionamento dei due principali dispositivi,
l’otturatore e il diaframma, bisogna ora far presente che esiste sempre una
relazione tra loro.
Per
chiarire meglio questa relazione, possiamo paragonare la pellicola ad un
recipiente che deve essere riempito dì acqua (la luce) ed il diaframma ad un
rubinetto. Se dobbiamo riempire il nostro contenitore
con una certa quantità d'acqua (luce) aprendo poco il rubinetto (diaframma) il
flusso sarà ridotto e il tempo per riempirlo (tempo d'otturazione) sarà lungo;
viceversa, aprendo molto il nostro rubinetto il flusso sarà superiore e di
conseguenza il tempo sarà più breve. La coppia tempo diaframma viene indicata con il tempo di apertura dell'otturatore
insieme al valore di apertura del diaframma (ad es. 1/125 f/8).
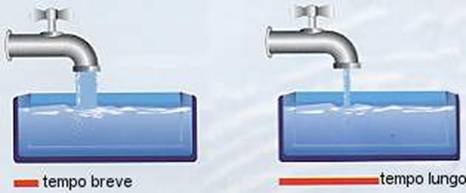
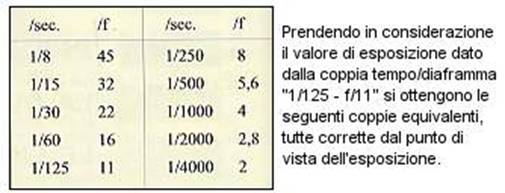
Dall'esempio
fotografico si capisce facilmente come si possano
ottenere valori d'esposizione equivalenti utilizzando coppie tempo / diaframma
differenti. In pratica un dato valore di esposizione,
come può essere quello ottenuto utilizzando un'apertura del diaframma pari a
f/11 ed un tempo di otturazione di 1/125 di secondo, può essere ottenuto
impiegando un tempo di otturazione più lungo, come 1/60 di secondo, ma con
un'apertura relativa del diaframma più piccola, pari a f/16. Viceversa,
utilizzando un tempo più rapido, ad esempio 1/250 di secondo, si otterrà
un'esposizione equivalente alla precedente aprendo il diaframma al valore f/8.
Ferme restando le medesime condizioni di luce si possono dunque individuare numerose coppie tempo/diaframma diverse fra loro ma
equivalenti in termini d'esposizione.