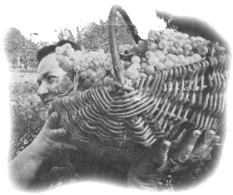Storia del Vino
|
|
|
||||
|
Origine
della viticoltura e della vinificazione La
Mesopotamia La coltivazione della vite volta alla produzione del vino si situa intorno al 4000 a.C., risalendo addirittura al 6000 a.C. nelle regioni montuose del Mar Nero e del Mar Caspio, in una zona delimitata dagli stati odierni della Turchia, Siria, Iraq, Iran e Russia. Anche se è solo una congettura, è probabile che il vino sia stato casualmente scoperto da qualcuno che deve aver bevuto il succo fermentato dell’uva selvatica, raccolto e conservato, probabilmente in un contenitore di terracotta. Questo potrebbe essersi verficicato molto prima della coltivazione intenzionale della vite, magari attorno all’ 8000 – 10000 a.C. Quella probabile patria della vinicoltura potrebbe essere identificata a nord delle grandi pianure del Tigri e dell’Eufrate, che si trovavano al centro degli imperi sumerico, accadico, assiro e babilonese, e anche a est dell’impero ittita, ovvero in corrispondenza dell’attuale Turchia. E’ nelle testimonianze che ci restano di quelle culture che possiamo trovare i primi dati concreti della viticoltura e della vinificazione. L'Egitto Le genti dell’Egitto dinastico ci hanno lasciato splendidi documenti iconografici relativi alla viticoltura, e questo non solo nelle pietre tombali ma anche nei tanti papiri, nelle innumerevoli statue. Come anche in Mesopotamia, la birra era la bevanda alcolica principale dell’Egitto antico, ma tra la fine del IV millennio e al principio del III il vino compare come bevanda usata dai re e dai sacerdoti e vicino alle strutture templari dei re della I Dinastia sorgono grandi cantine. La pratica egiziana di conservare il vino in apposite giare di ceramica sigillata ci ha fornito una messe straordinaria di informazioni relative ai luoghi di origine di quei vini. Durante il III millennio e la prima metà del II millennio sembra che i vigneti fossero essenzialmente di proprietà del re, dei sacerdoti e di qualche grande funzionario. Le viti venivano coltivate o nei giardini adiacenti alle case o in vigneti separati. La viticoltura in Siria e in Anatolia Mesopotamia ed Egitto hanno conservato le prime e le migliori testimonianze antiche relative a viticoltura, vinificazione e consumo di vino. Comunque è chiaro che la popolazione di quei paesi importava grandi quantità di vino dall’estero, in particolare, verso la metà del III millennio a.C., molta parte del vino consumato in Egitto arrivava dalla Palestina e dalla Siria. All’inizio del I millennio a. C., quando andarono al potere i Fenici, un popolo di marinai, i vini libanesi venivano commerciati dappertutto nel Mediterraneo. Il vino nell’economia greco-romanaVerso il XV secola a.C., con l’avanzare della potenza micenea la viticoltura fu introdotta anche in Grecia e proprio i Micenei furono i protagonisti dei poemi epici omerici in cui è descritta l’importanza del vino nelle libagioni e nei banchetti. In seguito si diffuse il culto di Dionisio che da dio della vite e del vino divenne presto anche la forza primaria della natura e, sotto il nome di Bacco si diffuse nel mondo romano (i riti a Bacco ebbero anche, per evidenti ragioni di ordine pubblico, momenti di proibizione e di limitazioni). Dal momento in cui la viticoltura fu introdotta nella Grecia peninsulare, la vite s’impose immediatamente, insieme al grano e alle olive, come uno dei tre prodotti basilari dell’economia agricola del Mediterraneo. Nell’ VIII secolo a.C., periodo a cui risalgono le prime testimonianze letterarie sull’agricoltura, è chiaro che la viticoltura e la vinificazione erano già ampiamente diffuse in Grecia. Esiodo nelle Opere e i giorni, ci offre il primo resoconto dettagliato sull’agricoltura greca, associando i consigli agricoli ai commenti politici e sociali, alle superstizioni e alle massime morali. Nella sua descrizione dell’anno del contadino Esiodo ricorda, fra le altre incombenze, la potatura della vite e i tempi della vendemmia nella Beozia, sua terra natale. Si sa molto sulla pratica della viticoltura in Grecia, non molto invece sull’estensione geografica di quella pratica. Sembra accertato che, ai tempi di Esiodo e di Omero la viticoltura era praticata un po’ dappertutto in Grecia, dalla Tracia alla Beozia all’Arcadia. Inoltre sembra che la maggior parte dei contadini coltivasse almeno qualche vite per produrre il proprio vino. Lo sviluppo delle grandi città stato come Tebe, Atene, Argo e Sparta, poi avrebbe fornito i centri della domanda per questo prodotto e sembra ragionevole ipotizzare che attorno a quelle città siano nati i primi vigneti specializzati e i primi produttori di vino. Uno dei più famosi vini Greci dell’epoca è il Pramnio, citato da Omero nell’Iliade, nell’isola di Lesbo si produceva il vino Omphacites, nell’isola di Cos un vino asprigno e in quella di Chios un vino molto resinato. I Greci aggiungevano ai loro vini una gran varietà di aromi e di sostanze diluenti, fra cui acqua di mare, spezie, miele e resina. Con la fondazione di colonie nell’Italia meridionale, la viticoltura si e’ sviluppata anche qui tanto da fare definire a Erodoto queste terre come Enotria. Nel 600 a.C., con la fondazione di Massilia, fu introdotta la coltivazione nel sud della Francia in una terra che avrebbe avuto il primato della produzione in epoca medioevale e moderna.
L’importanza
della viticoltura per l’economia agricola romana è sottolineata
dai trattati agricoli latini, in particolare De
agricultura di Marco Porcio Catone, scritto nel II sec. A.C.,
dal Res rusticae di Marco Terenzio Varrone e De re rusrica di Lucio Giunio Columella. Scritto nel I secolo d.C. Catone, Varrone e Columella forniscono una ricca serie di informazioni riguardo alla pratica della viticoltura e alla classificazione dei diversi tipi di vino fatti con diversi tipi di uva che verranno ampliate da Strabone in Geographica e da Olinio il Vecchio in Naturalis Historiae. L’impressione che si ricava dagli scritti di Strabone e di Plinio è che la vite era coltivata in gran parte dell’Europa meridionale e inj Turchia durante il I secolo: Mentre la tradizione riteneva migliori i vini dell’Egeo e quelli greci in generale, Plinio registra che fin dalla prima metà del I secolo a.C., i vini italiani avevano cominciato a godere di pari fama, Plinio segnala anche che la Spagna cominciava ad emergere tra i grossi produttori e nuove specie di vite venivano impiantate nella provincia narbonese. La maggior parte dei vigneti citati da Plinio e Strabone si trovava in località costiere o vicine al corso di grandi fiumi, questo per facilitare il trasporto del vino, in Gallia la viticoltura si diffuse nei secoli successivi proprio in zone attorno a grandi fiumi (Senna, Looira, Garonna, Rodano, Mosella) e di grandi vie di comunicazione. L’introduzione della vite in Grecia e poi nel mondo Romano modificò progressivamente il significato economico e sociale del vino che prima era stato privilegio delle classi al potere e poi divenne disponibile per tutti gli strati sociali. Mentre la comparsa della viticoltura era stata strettamente legata all’introduzione del rituale e del simbolismo dionisiaco nella penisola greca, la sua diffusione successiva fu in gran parte dovuta al desiderio di profitto dei produttori e dei mercanti greci e romani.
Il vino e la viticoltura nell’alto Medioevo Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente nel V secolo, la viticoltura è sopravvissuta quasi solo grazie al significato simbolico che il vino aveva nella religione cristiana, alla continuazione nel Nuovo Testamento del tema che paragona gli Ebrei a una vigna, alla parabola della vite e dei tralci; la continuazione della viticoltura, grazie a monaci diligenti ha poi introdotto il vino presso i Barbari. Nell’Impero di Oriente invece le tradizioni viticole continuarono indisturbate. L’avvento dell’Islam e la proibizione del vino, basata sul Corano, modificarono nelle zone di influenza dell’Islam i costumi ma sopravvisse la coltivazione dell’uva e, in piccola parte anche la vinicoltura. La
viticoltura e il commercio del vino nel Medioevo La storia del vino nel Medioevo, a parte piccole variazioni locali, e’ legata alla differenziazione tra paesi del Nord, più orientati a una produzione per la commercializzazione e i paesi del Sud Europa dove il sistema feudale era più legato alla sussistenza, inoltre ci sono state differenziazioni dovute al clima (vitigni che davano vino bianco più resistenti al freddo e all’umidità al nord) e sono iniziate differenziazioni di qualità e di fama delle singole zone (vini spagnoli e mediterranei definiti “generosi”, diffusione di vitigni in zone delimitate – ad. Es. Trebbiano in Toscana e nelle Marche, Vernaccia in Liguria, Schiava nella valpadana). Nella prima parte del Medioevo la viticoltura e il vino hanno trovato difesa e apporto di qualità e conservazione nei Monasteri, nelle Corti, negli ambienti ecclesiastici; con il ritorno alla vita cittadina il vino ha ripreso una posizione di status sociale tra la borghesia delle città. Nel Medioevo, accanto all’uso legato alle tradizioni religiose e all’uso come status-simbol nelle città, il vino riprese anche un preciso significato come farmaco (già avviato nell’antichità da Ippocrate e Galeno) . L’età modernaL’epoca delle scoperte e delle esplorazioni aprì nuove prospettive alla viticoltura e al consumo del vino sia verso le nuove terre che verso l’oriente. Il passaggio dal feudalesimo ad uno nuovo sistema economico aprì nuove prospettive alla coltivazione della vite (con conseguenti sistemi di rapporto tra i contadini e i proprietari terrieri) e al commercio del vino, elemento in grado di creare notevole profitto ed immagine (nascita di fiere specifiche nelle zone di produzione) Le
vicende politiche europee e il rapporto tra le potenze conquistatrici
di nuove terre ( soprattutto l’integrazione della Spagna nell’Impero
Asburgico) provocò uno sviluppo sia dell’aspetto commerciale per
i vini che una diffusione e un interscambio nella viticoltura.. Il vino distillato, probabilmente arrivato dal mondo arabo – alcool e alambicco derivano da parole arabe- ma probabilmente già conosciuto tra i Greci, e’ stato usato solo come medicinale sino al XV secolo quando, prima in Germania e poi in Francia e’ sfuggito dal controllo esclusivo degli alchimisti per diventare prodotto di consumo (e sono cominciate le leggi contro il consumo eccessivo…) . Oltre alla produzione di distillati (a quelli di vino sono seguiti quelli di cereali) e alla sviluppo della viticoltura in luoghi nuovi (nel vecchio e nuovo mondo), nel XVII secolo si vide la creazione di nuovi tipi di vino (i più significativi porto e champagne) e iniziò la ricerca di metodi e tecnologie per la conservazione e l’invecchiamento (con conseguente cambio delle caratteristiche organolettiche) del vino. Nel XVII si sono iniziate e a diffondere, pur essendo conosciute sin dai tempi romani, le bottiglie di vetro e i tappi di sughero modellati. La praticità di trasporto e commercio in botti e la praticità di invecchiamento e consumo delle bottiglie hanno posto le condizioni perché, accanto alla produzione e al commercio del vino sorgesse lo spazio per attività di imbottigliamento e conservazione al minuto (nascita della industria vinicola in parte slegata e distante dalle zone dei vigneti.). Nel XIX secolo avvennero, insieme ad una generale ristrutturazione della viticoltura in Europa, due importanti fatti: la diffusione dei vini passiti, portati in Europa dall’America del Nord e la introduzione ed espansione della viticoltura in nuove aree del globo, soprattutto Australia e California. Nell’Ottocento fecero anche comparsa in modo diffuso le frodi vinicole e iniziarono anche delle precise classificazioni dei vini. Nella seconda metà del secolo comparve anche la fillossera che provocò grosse crisi nella viticoltura e che fu risolta con radicali trasformazioni nella coltivazione della vite (innesti …). Alla fine del XIX secolo l’industria enologica era afflitta da crisi ricorrenti di sovrapproduzione, il fattore determinante nel determinare il prezzo dei vini scadenti destinati al consumo di massa era la maggiore o minore abbondanza della vendemmia annuale, mentre il prezzo dei vini migliori era determinato in gran parte dalla qualità delle annate. Per la tendenza alle variazioni di prezzo a seconda delle condizioni climatiche, il vino è diventato economicamente un prodotto diverso dalla birra e dalle altre bevande alcooliche. Nella seconda metà del XX secolo, malgrado i tentativi già fatti per classificare e demarcare i vini, restavano il problema degli additivi chimici aggiunti per mascherare o variare i sapori e il problema che alcuni vini che dichiaravano una certa origine, in realtà provenivano da luoghi diversi da quelli dichiarati. Per risolvere questi problemi, sono state definite precise zone di origine (lo champagne è solo di una certa zona francese…) a cui sono state assegnate sigle specifiche ( DOC, DOCG, IGT, VQPRD, VSQPRD ….). |
|||||