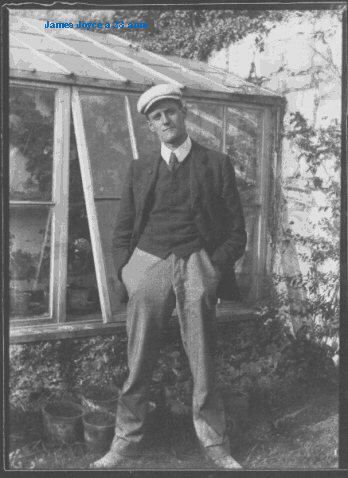 Quando, nel 1905,
al quarantenne commerciante Ettore Schmitz fu consigliato il giovane insegnante
di inglese James Joyce della Berlitz School di Trieste, lo scrittore Italo
Svevo sembrava morto e sepolto sotto l'indifferenza che aveva accolto i suoi
primi due romanzi. Fra i due letterati nacque però ben presto un rapporto
di intensa amicizia e di stima reciproca che sarebbe sfociato in una
collaborazione alquanto fruttuosa per entrambi.
Quando, nel 1905,
al quarantenne commerciante Ettore Schmitz fu consigliato il giovane insegnante
di inglese James Joyce della Berlitz School di Trieste, lo scrittore Italo
Svevo sembrava morto e sepolto sotto l'indifferenza che aveva accolto i suoi
primi due romanzi. Fra i due letterati nacque però ben presto un rapporto
di intensa amicizia e di stima reciproca che sarebbe sfociato in una
collaborazione alquanto fruttuosa per entrambi.
Essendo infatti venuto a sapere che fra i suoi allievi vi era uno scrittore,
il ventenne ma già affermato Joyce chiese a Svevo di poter leggere
i suoi manoscritti. Lo scrittore triestino acconsentì e la reazione
dell'irlandese fu di assoluto entusiasmo: incoraggiò l'amico a non
abbandonare la scrittura e gli sottopose le sue poesie ed i racconti di
Dubliners. Racconta Livia Veneziani Svevo, in Vita di mio marito:
"Fra il maestro, oltremodo irregolare, ma d'altissimo ingegno (conosceva
diciotto lingue tra antiche e moderne), e lo scolaro d'eccezione, le lezioni
si svolgevano con un andamento fuori dal comune...Si parlava di letteratura
e si sfioravano mille argomenti".
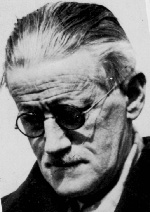 Fu probabilmente
grazie agli incoraggiamenti di Joyce che Svevo portò a termine La
coscienza di Zeno e che reagì all'indifferenza con cui l'universo
letterario italiano accolse anche il suo terzo romanzo. Convinto della
bontà della sua opera, spedì una copia all'amico che la guerra
aveva costretto al soggiorno in Francia. Questi fece conoscere l'opera ai
suoi amici critici letterari francesi Valery Larbaud e Benjamin Cremieux
i quali, anche sulla base dell'operazione pubblicitaria dell'irlandese, rimasero
affascinati da quest'ultima opera e ne proposero a Svevo un'edizione in francese.
Fu probabilmente
grazie agli incoraggiamenti di Joyce che Svevo portò a termine La
coscienza di Zeno e che reagì all'indifferenza con cui l'universo
letterario italiano accolse anche il suo terzo romanzo. Convinto della
bontà della sua opera, spedì una copia all'amico che la guerra
aveva costretto al soggiorno in Francia. Questi fece conoscere l'opera ai
suoi amici critici letterari francesi Valery Larbaud e Benjamin Cremieux
i quali, anche sulla base dell'operazione pubblicitaria dell'irlandese, rimasero
affascinati da quest'ultima opera e ne proposero a Svevo un'edizione in francese.
Nel giro di pochi mesi il nome di Svevo cominciò a circolare sempre
più frequentemente nei circoli culturali francesi e, di conseguenza,
europei; solo in Italia, dove solo il giovane Montale sembrò accorgersi
di lui, non gli venne tributata la giusta fama.
 Il fatto
che Svevo e Joyce si conoscessero e confrontassero le loro idee non deve
far pensare che Svevo fosse il Joyce italiano, ovvero che la Coscienza
di Zeno e l'Ulysse non siano altro che due realizzazioni della
stessa tecnica letteraria. Il capolavoro di Joyce propone una tecnica narrativa
rivoluzionaria, quella del monologo interiore, e pure nella Coscienza
v'è un personaggio che monologa. Le somiglianze si limitano però
quasi solo a questo: i due romanzi sono profondamente diversi perché
diverse sono le tecniche con cui vengono tratteggiate le coscienze di Leopold
Bloom e Zeno Cosini.
Il fatto
che Svevo e Joyce si conoscessero e confrontassero le loro idee non deve
far pensare che Svevo fosse il Joyce italiano, ovvero che la Coscienza
di Zeno e l'Ulysse non siano altro che due realizzazioni della
stessa tecnica letteraria. Il capolavoro di Joyce propone una tecnica narrativa
rivoluzionaria, quella del monologo interiore, e pure nella Coscienza
v'è un personaggio che monologa. Le somiglianze si limitano però
quasi solo a questo: i due romanzi sono profondamente diversi perché
diverse sono le tecniche con cui vengono tratteggiate le coscienze di Leopold
Bloom e Zeno Cosini.
Leggendo una pagina dell'Ulysse possiamo notare come lo "Stream of
Consciuossness" joyciano consista in una descrizione in terza persona delle
azioni del protagonista nella quale si inseriscono senza connessione sintattica
i suoi pensieri che, privi di ogni ordinamento logico, si limitano a riflettere
le sue associazioni mentali. I pensieri sono pertanto colti nel loro nascere
e sono riportati senza alcun controllo da parte della ragione.
 E'
proprio qui che sta la grande differenza tra l'Ulysse e La
Coscienza: Zeno scrive un'autobiografia. Le sue parole nascono quindi
sotto il rigido controllo della coscienza che censura, cambia e riordina
gli avvenimenti in modo che possano risultare il più possibile favorevoli
al protagonista. Come se ciò non bastasse, Zeno non scrive per se
stesso ma per il dottor S.: anche questo lo obbliga a filtrare il
suo racconto e ad erigere barriere che impediscano il libero fluire dei pensieri.
E'
proprio qui che sta la grande differenza tra l'Ulysse e La
Coscienza: Zeno scrive un'autobiografia. Le sue parole nascono quindi
sotto il rigido controllo della coscienza che censura, cambia e riordina
gli avvenimenti in modo che possano risultare il più possibile favorevoli
al protagonista. Come se ciò non bastasse, Zeno non scrive per se
stesso ma per il dottor S.: anche questo lo obbliga a filtrare il
suo racconto e ad erigere barriere che impediscano il libero fluire dei pensieri.
Queste differenze si riflettono anche sulla sintassi delle opere. Se Joyce
arriva a far esplodere la sintassi e ad abolire per lunghi tratti la
punteggiatura, nel racconto di Zeno tutti i nessi logici rimangono. Lo scrittore
irlandese inoltre si diverte a sperimentare: combina i registri più
lontani tra loro e gioca con suoni e parole, mentre l'eloquio di Zeno è
la lingua colloquiale della borghesia triestina.
Concludendo, i collegamenti tra le due opere sono generici e limitati
all'interpretazione di uno stesso clima culturale di inizio Novecento che,
abbandonata la visione del mondo positivista, ama esplorare le profondità
della psiche umana rivoluzionando le tecniche di scrittura alla luce di questa
ricerca. Ciascuno dei due scrittori ha però saputo interpretare
peculiarmente e sapientemente questo comune clima generale.
Inizio pagina
Italo Svevo
Menù principale
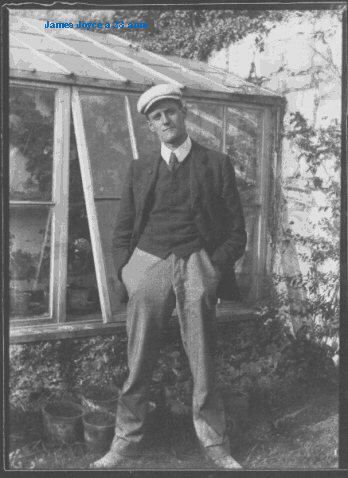 Quando, nel 1905,
al quarantenne commerciante Ettore Schmitz fu consigliato il giovane insegnante
di inglese James Joyce della Berlitz School di Trieste, lo scrittore Italo
Svevo sembrava morto e sepolto sotto l'indifferenza che aveva accolto i suoi
primi due romanzi. Fra i due letterati nacque però ben presto un rapporto
di intensa amicizia e di stima reciproca che sarebbe sfociato in una
collaborazione alquanto fruttuosa per entrambi.
Quando, nel 1905,
al quarantenne commerciante Ettore Schmitz fu consigliato il giovane insegnante
di inglese James Joyce della Berlitz School di Trieste, lo scrittore Italo
Svevo sembrava morto e sepolto sotto l'indifferenza che aveva accolto i suoi
primi due romanzi. Fra i due letterati nacque però ben presto un rapporto
di intensa amicizia e di stima reciproca che sarebbe sfociato in una
collaborazione alquanto fruttuosa per entrambi.
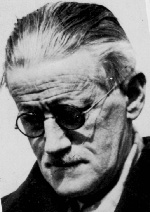 Fu probabilmente
grazie agli incoraggiamenti di Joyce che Svevo portò a termine La
coscienza di Zeno e che reagì all'indifferenza con cui l'universo
letterario italiano accolse anche il suo terzo romanzo. Convinto della
bontà della sua opera, spedì una copia all'amico che la guerra
aveva costretto al soggiorno in Francia. Questi fece conoscere l'opera ai
suoi amici critici letterari francesi Valery Larbaud e Benjamin Cremieux
i quali, anche sulla base dell'operazione pubblicitaria dell'irlandese, rimasero
affascinati da quest'ultima opera e ne proposero a Svevo un'edizione in francese.
Fu probabilmente
grazie agli incoraggiamenti di Joyce che Svevo portò a termine La
coscienza di Zeno e che reagì all'indifferenza con cui l'universo
letterario italiano accolse anche il suo terzo romanzo. Convinto della
bontà della sua opera, spedì una copia all'amico che la guerra
aveva costretto al soggiorno in Francia. Questi fece conoscere l'opera ai
suoi amici critici letterari francesi Valery Larbaud e Benjamin Cremieux
i quali, anche sulla base dell'operazione pubblicitaria dell'irlandese, rimasero
affascinati da quest'ultima opera e ne proposero a Svevo un'edizione in francese.
 Il fatto
che Svevo e Joyce si conoscessero e confrontassero le loro idee non deve
far pensare che Svevo fosse il Joyce italiano, ovvero che la Coscienza
di Zeno e l'Ulysse non siano altro che due realizzazioni della
stessa tecnica letteraria. Il capolavoro di Joyce propone una tecnica narrativa
rivoluzionaria, quella del monologo interiore, e pure nella Coscienza
v'è un personaggio che monologa. Le somiglianze si limitano però
quasi solo a questo: i due romanzi sono profondamente diversi perché
diverse sono le tecniche con cui vengono tratteggiate le coscienze di Leopold
Bloom e Zeno Cosini.
Il fatto
che Svevo e Joyce si conoscessero e confrontassero le loro idee non deve
far pensare che Svevo fosse il Joyce italiano, ovvero che la Coscienza
di Zeno e l'Ulysse non siano altro che due realizzazioni della
stessa tecnica letteraria. Il capolavoro di Joyce propone una tecnica narrativa
rivoluzionaria, quella del monologo interiore, e pure nella Coscienza
v'è un personaggio che monologa. Le somiglianze si limitano però
quasi solo a questo: i due romanzi sono profondamente diversi perché
diverse sono le tecniche con cui vengono tratteggiate le coscienze di Leopold
Bloom e Zeno Cosini.
 E'
proprio qui che sta la grande differenza tra l'Ulysse e La
Coscienza: Zeno scrive un'autobiografia. Le sue parole nascono quindi
sotto il rigido controllo della coscienza che censura, cambia e riordina
gli avvenimenti in modo che possano risultare il più possibile favorevoli
al protagonista. Come se ciò non bastasse, Zeno non scrive per se
stesso ma per il dottor S.: anche questo lo obbliga a filtrare il
suo racconto e ad erigere barriere che impediscano il libero fluire dei pensieri.
E'
proprio qui che sta la grande differenza tra l'Ulysse e La
Coscienza: Zeno scrive un'autobiografia. Le sue parole nascono quindi
sotto il rigido controllo della coscienza che censura, cambia e riordina
gli avvenimenti in modo che possano risultare il più possibile favorevoli
al protagonista. Come se ciò non bastasse, Zeno non scrive per se
stesso ma per il dottor S.: anche questo lo obbliga a filtrare il
suo racconto e ad erigere barriere che impediscano il libero fluire dei pensieri.