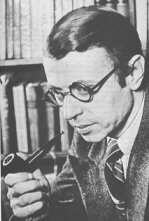
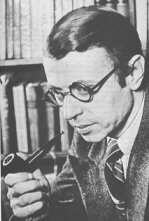
Collegandosi alla tradizione
del pensiero francese, Sartre inizia "L'Être et Le Néant"
con il cogito cartesiano. "Io penso, dunque sono", questa è la verità
assoluta della coscienza che raggiunge se stessa, tuttavia egli introduce
una correzione importantissima: facendo riferimento alla fenomenologia
husserliana, che considerava la coscienza come essenzialmente "intenzionale",
Sartre afferma che, "nel momento in cui conosco, ho anche la consapevolezza
di conoscere". E' una coscienza originaria, poichè essa è
anzitutto coscienza di se stessa come conoscente e, essendo anteriore al
pensiero concettuale, è anzitutto un modo di esistere, perciò
essa è anche anteriore all'essere.
L'uomo è l'unico
ente nel quale l'esistenza precede l'essenza; è dunque un essere
indeterminato che si definisce, cioè costituisce la propria essenza,
in base alle libere scelte.
La coscienza è
perciò anche consapevolezza che vi è qualcosa di altro da
lei stessa, che vi è l'essere. Di qui le due grandi zone dell'essere:
la coscienza pura (l'essere per sè) e la coscienza di qualcosa,
ossia l'essere di cui la coscienza è consapevole (essere in sè).
Fra i due vi è sempre uno scarto radicale: la coscienza, che è
continuamente tesa verso qualcosa che non è ancora e, nel progettarsi
e proiettarsi al di fuori di sè, verso il futuro, verso la propria
realizzazione, tende anche a raggiungere una situazione di stabilità,
ma ciò è impossibile. Essa non riesce mai ad identificarsi
con se stessa perchè le "manca qualcosa".
E' proprio questa carenza,
questo nulla la struttura della coscienza, a cui è legato il destino
umano. Il desiderio del resto ne è la prova: l'esistente-uomo è
sempre teso verso qualcosa di diverso da acquisire; ma d'altronde questo
qualcosa non è una realtà relativa, deve essere una realtà
assoluta. Raggiunta questa realtà la coscienza umana perderebbe
ogni dinamicità, diventerebbe una cosa, un essere, si avrebbe la
coincidenza dell'in-sè e del per-se.
La coscienza dunque trapassa,
supera, non dipende dagli oggetti (essere in sè) pertanto è
libera, ma ciò è una condanna, perchè comporta la
responsabilità delle scelte, di ciò che accade. Gli altri
sono un ostacolo alla libertà; ma anche le condizioni oggettive
dell'esistenza, i condizionamenti materiali di ogni tipo e lo stesso passato
costituiscono dei limiti; tuttavia essi non sono condizionamenti insuperabili
perché l'uomo può utilizzarli come vuole. L'unico limite
veramente insuperabile, contro il quale non si può nulla, è
la morte, che per Sartre, è al di fuori di ogni orizzonte di scelte,
non riguarda la libertà, quindi non riguarda l'uomo. Essa rende
assurde tutte le scelte di vita, toglie loro ogni senso.
Tuttavia, al di là
di questo limite, "io sono libero nel mondo più assoluto e totale".
Vi è solo una cosa della quale non sono libero: quella di non essere
libero; siamo condannati ad essere liberi. In questo sta tutto il dramma
della vita umana, perchè nessuno può scegliere al posto mio,
e del resto la mia responsabilità comporta anche una dimensione
sociale, perché gli altri dipendono anche dalle mie scelte. La condizione
della scelta, ossia la tensione senza fine verso il futuro, genera angoscia
come "continuo mettersi in gioco" e il senso di nausea, sentimento attraverso
cui l'esistenza si manifesta nella sua assurdità e contingenza,
nella sua mancanza di senso.
E' soprattutto nei suoi
drammi che Sartre ha saputo trasporre le sue tesi filosofiche, traducendole
in personaggi e situazioni di estrema plasticità e immediatezza
comunicativa.
Il teatro di Sartre: il teatro della situazione