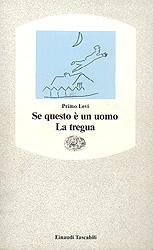
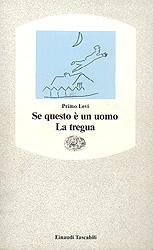
Il libro inizia con l'arrivo dei Russi al campo di Buna-Monowitz, quattro
giovani soldati a cavallo che osservano sbigottiti e increduli dall'alto
di un colle, il 27 Gennaio 1945, mentre Levi e un altro sopravvissuto stanno
trasportando alla fossa comune un compagno morto durante la notte.
La storia prosegue con la rievocazione degli avvenimenti accaduti dopo
l'avvento dei Russi: giungono i primi rifornimenti, i primi soccorsi, pagarre
polacche si aggirano per il campo occupandosi dei superstiti. I prigionieri
ancora in vita, i malati, i moribondi vengono trasferiti al Campo Grande
di Auschwitz ("una sterminata metropoli" al cui confronto Buna-Monowitz
sembra un villaggio), in cui l'autore, appena giunto, si ammala dove avrà
modo di conoscere molti personaggi.
Ristabilitosi, abbandona il campo aggregandosi a coloro che sono in grado
di affrontare il viaggio di ritorno nei rispettivi paesi. Ma ha inizio
così quella estenuante odissea che lo avrebbe condotto per circa
un anno attraverso l'Europa Orientale, facendolo partecipe di avventure
assurde; e rendendo il rimpatrio come un miraggio, e ambientando la narrazione
in episodi e figure da incubo, a rendere suggestivo il racconto è
lo sfondo in cui si muove: un'Europa devastata, un paesaggio in disfacimento
che presenta ovunque i segni della recente catastrofe e dove si collocano
uomini sconvolti dalla guerra.
Nel corso dei suoi spostamenti da un campo di raccolta ad un altro viene
a contatto con uomini che egli definisce "esemplari scaleni, difettivi,
abnormi". Ad esempio la figura del Greco, un'Ebreo di Salonicco, con il
quale l'autore trascorre una "settimana randagia" giungendo dapprima a
Tracara, quindi a Katowice. Un'altra figura è quella di Marja Fjodorovna
che incontra nel campo di sosta di Katowice e con la quale collabora per
un certo tempo come "farmacista" presso l'infermeria dello stesso campo.
Sempre qui conosce l'Italiano Cesare con il quale instaura una solida amicizia.
È Cesare che lo introduce nel mercato nero di Katowice. Qui la situazione
diventa meno tesa e l'angoscia lentamente si trasforma in una momentanea
serenità. Nel Maggio del 1945, la guerra ha fine. La natura esplode
"come un uragano" nel campo i russi si lasciano trasportare dall' euforia
e organizzano festeggiamenti e spettacoli. Ma poco dopo Levi si ammala
di pleurite ed è in questa occasione che incontra altri singolari
personaggi, come il dottor Gottlieb che esercitava la professione di medico
proprio a Katowice. In quei giorni, fu comunque un vecchio Italiano soprannominato
il Moro di Verona, ad attirare la sua attenzione.
Sul finire della primavera, dopo quattro mesi di attesa nel medesimo campo,
giunge la notizia del rimpatrio. I reduce Italiani, circa ottocento, con
"fragorosa allegria" salgono nei vagoni merci in partenza per Odessa dove
li attende un treno che, come molti dicono, dovrebbe portarli in Italia.
Ma ciò non accade in quanto il treno non giunse mai ad Odessa. Alla
stazione di Emermka nella Russia Bianca, dopo sei giorno di viaggio in
condizioni alquanto sgradevoli, i reduci apprendono che il convoglio non
può proseguire.
Intraprendono così un viaggio verso Nord, che di tappa in tappa,
li conduce nella splendida località di Staryie Doroghi, che raggiungono
a piedi dopo aver sostato, per circa dieci giorni, a Slark. Giunti a Staryie
Doroghi, risiedono in un gigantesco edificio detto la casa Rossa, "piena
di misteri e trabocchetti come un castello di fate", situato in un luogo
ai margini di una foresta. Qui, sempre in attesa di un rimpatrio, sostano
per due mesi, fino al 15 Settembre del 1945. Finalmente arriva l'annuncio
della partenza e, dopo una notte di festeggiamenti, tutti gli Italiani
raccolti nel campo si dirigono alla stazione del piccolo villaggio dove
c'è un treno. Ma rimangono delusi quando si accorgono che il treno
ripercorre all'indietro le tappe del viaggio fatto in precedenza e ciò
conferma il disordine dell'organizzazione russa.
Il convoglio viaggia con molta lentezza, con continue soste e inciampi.
Giunto a Zmerinka, dove i superstiti alcuni mesi prima avevano già
trascorso giorni d'attesa angosciosi, anziché dirigersi verso il
centro-Europa, scende verso Sud, fin quasi alle sponde del mar Nero, per
poi risalire lentamente attraverso la Romania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia
e giungere a Vienna l'8 Ottobre, dopo un viaggio durato più di venti
giorni. Sia lo spettacolo d'un'Europa distrutta che i continui ricordi
dei reduci, fanno sembrare sempre più lontana la gioia del rimpatrio.
A Bratislava, vedendo quei monti che sbarravano il lugubre orizzonte di
Auschwitz, sono assaliti dall'angoscia, patiscono nuove sofferenze quando
il convoglio, lasciata l'Austria, entra in Germania e raggiunge Monaco.
Guardandosi attorno, osservando la gente che camminava per le strade, non
possono fare a meno di chiedersi se i Tedeschi sono a conoscenza di quanto
è avvenuto ad Auschwitz.
Le ultime pagine, quelle che narrano il passaggio del Brennero nella notte
del 16 Ottobre sono molto tristi, in quanto se La tregua sta per
concludersi, se la lunga odissea del rimpatrio sta per finire, per loro
il futuro rimane sconosciuto, levi si pone quindi della domande che consistono
in ciò che egli ha definito "il veleno di Auschwitz" e la ragione
per cui l'offesa subita è inguaribile e incancellabile nel tempo.
Le varie tappe, che dal campo di Auschwitz hanno condotto Levi e i suoi
compagni fino in Italia, rappresentano un viaggio di ritorno verso la civiltà,
verso un mondo lontano dalla violenza cieca e dalla brutalità bestiale;
è un lento risalire dall'annientamento umano in cui il lager lo
aveva cacciato, in cui agivano uomini che per noi lettori restano senza
nome e senza volto, come senza volto e senza nome restano le bestie feroci
che in taluni momenti il destino pone sul cammino degli uomini.
Per questo molte scene avvengono all'aria aperta, in spazi senza confini
visibili, nei quali si perde lo spirito annientato: ogni tanto accade che
lo spirito prenda coscienza della realtà, delle altre persone, e
allora ogni cosa appare come dominata da un grande senso di ingenuità,
come quella provata da chi per la prima volta prova certi sentimenti, per
la prima volta vede certe cose così diverse da quelle che avevano
occupato il suo animo nei mesi o negli anni di lager.
Il lager dà una configurazione nuova allo spirito, costringendolo
entro confini precisi di oppressione, convincendolo che null'altro possa
esistere al di fuori di quelle regole, di quegli atteggiamenti e di quei
confini. Durante il viaggio si riscopre l'altra configurazione della realtà,
che esisteva prima del lager, ma che era stata violentemente cacciata via
dalla mente con un immediato e brutale processo di disumanizzazione, di
"animalizzazione". Queste due configurazioni entrano spesso in conflitto,
senza che l'una prenda decisamente il sopravvento sull'altra; la "normalità"
sarà sempre dominata da un senso di angoscia provocato da quel processo,
che ogni tanto rivive anche se la volontà cerca di farlo diventare
oscuro per sempre.
Lo stesso autore ci spiega i motivi per cui ha dato al libro il titolo
La
tregua, nelle pagine conclusive quando rammenta le sensazioni che ha
provato con i suoi compagni di viaggio nel momento in cui il treno è
entrato in Italia. La tregua è infatti un'odissea, il ritorno
inteso come travaglio interiore, lotta contro i ricordi, la ricerca della
propria persona, dell'integrità umana calpestata ed avvilita. Ma
la tregua è anche quel momento di sospensione fra l'una e
l'altra configurazione dello spirito che abbiamo già visto, il momento
della normalità intima.
"I mesi or ora trascorsi, pur duri, di vagabondaggio ai margini della civiltà,
ci apparivano adesso come una tregua, una parentesi di illimitata disponibilità,
un dono provvidenziale ma irripetibile del destino"; il dono di uno stacco
tra ciò che era rappresentato dall'inferno del lager e il ritorno
alla "normalità" conquistata e assaporata a poco a poco nel corso
di un viaggio di circa cinquemila chilometri in quasi nove mesi: un viaggio
di nove mesi per il ritorno alla vita.
Ma il ritorno alla vita sarà sempre dominato da una voce ben nota
e da "una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommossa. È il
comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa:
alzarsi, «Wstawac»".
L'indignazione scaturita non tanto dagli effetti delle atrocità compiute da altri, quanto dagli effetti che ne conseguono e che conducono coloro che le hanno subìte a provare un senso di vergogna. Il tema dell'amore si presentava come "simbolo inconsapevole di una libertà perduta e non più sperata."
È un libro che narra della libertà tanto sperata nei campi di concentramento. Primo Levi con questo seguito vuole mostrare il cambiamento che i superstiti hanno subìto dopo la liberazione: ritrovano le forze e la speranza di un futuro, ritornano alle loro case anche se continuano ad essere tormentati da quei terribili ricordi. Durante questa odissea c'è chi intraprende la strada del commercio per procurarsi del denaro con il quale sopravvivere e chi ruba; ma nello stesso tempo si mescolano tra di loro, si aiutano l'un con l'altro e si compatiscono: sono così "tornati ad essere delle persone" con sentimenti, emozioni, desideri, in quanto possono finalmente pensare e riposare. Più si avvicinano alle proprie terre e più sono assaliti da sentimenti opposti: l'ottimismo e l'angoscia che qualcosa possa impedire loro il rimpatrio e infatti, all'inizio sono increduli del loro arrivo, ma infine riacquistano la loro sicurezza.