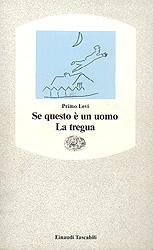 tra
la fine del 1945 e l’inizio del 1945. Narra le sue esperienze di deportato
nel Lager nazista di Buna-Monowitz nei pressi di Aushwitz, dall’arresto
avvenuto il 13 dicembre 1943, quando viene sorpreso in montagna, fino al
momento della sua liberazione dal Lager, il 27 gennaio 1945.
tra
la fine del 1945 e l’inizio del 1945. Narra le sue esperienze di deportato
nel Lager nazista di Buna-Monowitz nei pressi di Aushwitz, dall’arresto
avvenuto il 13 dicembre 1943, quando viene sorpreso in montagna, fino al
momento della sua liberazione dal Lager, il 27 gennaio 1945.
Nella prefazione Levi scrive:
“Questo mio libro, in fatto di particolari atroci, non aggiunge nulla a quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento dei campi di distruzione. Esso non è stato scritto allo scopo di formulare nuovi capi d’accusa; potrà piuttosto fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano.
(…) A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager.”
Il racconto delle sue drammatiche esperienze assume di volta in volta un andamento diverso: quello del resoconto, in cui gli avvenimenti ci vengono esposti nella loro successione cronologica; quello più aperto e disteso che procede per associazioni di memoria, in cui l’autore ci presenta la vita nel campo attraverso una serie di quadri che includono personaggi e situazioni; quello infine di impianto diaristico, adottato nelle ultime pagine, che meglio riproduce il precipitare degli eventi e meglio si adatta alla concitazione che assume il racconto.
Già il titolo rappresenta uno di quegli interrogativi della coscienza, la cui drammaticità è tale da rendere superfluo il punto di domanda. Infatti la testimonianza di Levi non è altro che una lunga meditazione sull’opera di annientamento della personalità umana - sia in senso fisico che, soprattutto, morale – che costituisce il primo obiettivo dei campi di sterminio.
Dopo averci descritto in termini lapidari come venne catturato dai fascisti e condotto al campo di concentramento di Fossoli, Levi affronta la descrizione del viaggio, in un convoglio di dodici carri affollati e chiusi dall’esterno, fino ad Auschwitz.
Giunti a destinazione, comincia il meccanismo dell’annientamento: coloro che possono essere sfruttati come mano d’opera, vengono condotti ai campi di lavoro; gli altri, vecchi, bambini, inabili, avviati alle camere a gas.
“Scomparvero così , in un istante, a tradimento, le nostre donne, i nostri genitori, i nostri figli. Quasi nessuno ebbe modo di salutarli. Li vedemmo un po’ di tempo come una massa oscura all’altra estremità della banchina, poi non vedemmo più nulla.”
Quelli abili vengono trasportati al campo di lavoro assegnato. Una insegna vivamente illuminata ARBEIT MACHT FREI (Il lavoro rende liberi) sovrasta la porta del campo. Dopo questo impatto beffardo e grottesco, i prigionieri vengono spogliati,non solo in senso metaforico, di ogni dignità umana, rivestiti di casacche a righe, con zoccoli, tatuati sul braccio sinistro con il numero di matricola che sostituirà il loro nome e servirà anche a cancellare la loro identità. Il nome dell’autore non è più Primo Levi, ma 174517.
“Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso.”
La narrazione prosegue addentrandosi nella descrizione di quell’inferno, difficilmente immaginabile per chi non ne abbia fatto esperienza. Il campo in cui viene rinchiuso l’autore è costituito da una quarantina di baracche, dette Blocks, destinate agli ebrei, e da altri alloggiamenti in cui i comandanti del campo (Kapos) e i prigionieri tedeschi di razza ariana, politici e criminali (Reichsdeutsche).
Tutti gli internati vengono trasferiti durante il giorno presso una fabbrica di gomma, la Buna. E sotto la sorveglianza di un Kapo, svolgono un lavoro massacrante. I più deboli presto soccombono alla fatica, alle privazioni, alle malattie e al freddo.
“Avevamo deciso di trovarci, noi italiani, ogni domenica sera in un angolo del Lager; ma abbiamo subito smesso, perché era troppo triste contarci e trovarci ogni volta più pochi, e più deformi, e più squallidi. Ed era faticoso fare quei pochi passi: e poi, a ritrovarsi, accadeva di ricordare e di pensare, ed era meglio non farlo”
Ma l’aspetto più tragico non è costituito, come si potrebbe pensare, dalla lotta giornaliera per la sopravvivenza, ma dal fatto che all’interno del Lager si riproducono le medesime strutture che governano qualsiasi tipo di società: il privilegio, l’ingiustizia, il sopruso, l’abilità personale, l’astuzia svolgono un ruolo determinante, dando luogo a una gerarchia di oppressori e oppressi. Le privazioni inferociscono gli animi e la degradazione travalica ogni limite.
La lotta per la vita, ridotta al suo meccanismo primitivo, si configura in termini biologici come uno spietato processo di selezione naturale dove tutte le sfumature si annullano e dove l’unico elemento di differenziazione tra gli uomini è determinato soltanto dalla capacità o incapacità di sopravvivere, evidenziando due sole categorie: i salvati e i sommersi.
“Nella storia e nella vita pare talvolta di discernere una legge feroce, che suona ‘A chi ha, sarà dato; a chi non ha, a quello sarà tolto’. Nel Lager, dove l’uomo è solo e la lotta per la vita si riduce al suo meccanismo primordiale, la legge iniqua è apertamente in vigore e riconosciuta da tutti.”
Incontriamo così l’ebreo galiziano Schepschel, che riesce a sopravvivere grazie ad espedienti e traffici di ogni genere, l’ingegnere Alfred L., che riesce a conquistarsi una posizione di preminenza, il giovane ed effemminato Henri, che ha compreso i tre metodi di sopravvivenza in quell’inferno che è il Lager: sapersi organizzare, praticare il furto con perizia sistematica e suscitare negli altri pietà.
Ma accanto alla schiera dei salvati, esiste quella, assai più estesa e spettrale dei sommersi, destinati a morte sicura. L’autore ce ne offre una tragica esemplificazione nella figura di “Zero Diciotto”, soprannominato così dalle ultimie cifre del suo numero di matricola. Egli è talmente indifferente a tutto che non reagisce più nemmeno ai maltrattamenti e lavora più degli altri, finchè le forze glielo permettono.
“Quando parla, quando guarda, dà l’impressione di essere vuoto interiormente, nulla più che un involucro, come certe spoglie di insetti che si trovano in riva agli stagni, attaccate con un filo ai sassi, e il vento le scuote”. E’ questa l’agghiacciante incarnazione della metamorfosi di un uomo sottoposto all’opera di stritolamento e annientamento messa in atto dal Lager.
Poi, primo Levi racconta che, trasportando un carico pesante dalla ferrovia al magazzino della fabbrica di gomma, cade e si ferisce un piede. Viene mandato all’infermeria, dove assiste all’annientamento dei malati. Trasferito in un altro Block, ha la fortuna di incontrare Alberto, il migliore amico che si è fatto nel campo, e con lui troverà il modo di essere assegnato al Kommando chimico, essendo lui laureato in chimica col massimo dei voti. Superato fortunatamente l’esame, benchè sostenuto in lingua tedesca, riesce ad evitare i lavori più pesanti.
L’autore raaconta anche il suo incontro con Lorenzo, un operaio civile italiano che lavorava alla fabbrica della gomma non in qualità di prigioniero e che, mosso a compassione e senza pretendere niente in cambio, per sei mesi ogni giorno gli procurò un pezzo di pane e gli avanzi del proprio rancio.
“ Io credo proprio a Lorenzo debbo di eesere vivo oggi; e non tanto per il suo aiuto materiale, quanto per avermi costantemente rammentato(…) che ancora esisteva un mondo giusto al di fuori del nostro…”
Un altro episodio molto intenso riguarda la “selezione” avvenuta nell’ottobre ‘44, quando le SS affrontano il problema di ridurre il numero dei prigionieri, in continuo aumento, che affollano il campo: Il sistema più sbrigativo è quello di sbarazzarsi dei prigionieri meno validi, inviandoli nelle camere a gas. Levi descrive questa scena agghiacciante: agli internati viene consegnata una scheda, dovranno sfilare nudi davanti ad un sottufficiale delle SS, il quale “con uno sgurdo di faccia e di schiena giudica della sorte di ognuno, e consegna a sua volta la scheda all’uomo alla sua destra o all’uomo alla sua sinistra, e questo è la vita o la morte di ciascuno di noi”.
Nel frattempo hanno inizio i bombardamenti alleati sull’Alte Slesia, tutto lascia presagire una prossima caduta del Terzo Reich. Il ritmo di lavoro dei prigionieri rallenta e si attenuano le sofferenze. Ma verso la fine del ‘44, dei novantasei italiani internati nel campo, solo ventuno sono ancora in vita, ma in condizioni tali che difficilmente riusciranno a sopravvivere per molto. L’autore ce la fa soltanto perché lavora al laboratorio chimico, ma
“la pena del ricordarsi, il vecchio feroce struggimento di sentirsi uomo, che mi assalta come un cane all’istante in cui la coscienza esce dal buio. Allora prendo la matita e il quaderno e scrivo quello che non saprei mai dire a nessuno”.
La prima stesura del romanzo risale infatti a questo periodo, in cui l’autore avverte la necessità di “sopravvivere” per poter “testimoniare”.
La narrazione di questo periodo si conclude con un episodio altamente drammatico: l’impiccagione di un uomo accusato di aver organizzato un complotto per l’ammutinamento dei prigionieri del campo. E gli altri deportati sono rimasti ad assistere, senza dare alcun segnale di solidarietà.
Poi il racconto assume un ritmo diverso, il fronte russo si sta avvicinando e i tedeschi sono coscienti della loro imminente caduta. Secondo le istruzioni impartite da Himmler fanno evacuare i campi di sterminio e distruggono gli impianti, affinché non rimanga traccia dei Lager. Gli avvenimenti vengono narrati in forma di diario.
L’autore intanto si è ammalato si è ammalato di scarlattina ed è ricoverato nelle baracche adibite ad ospedale. Assiste alla partenza di circa ventimila compagni, che moriranno tutti, come era nei piani, durante un’interminabile marcia attraverso la Germania. I malati, circa ottocento, rimangono nel Lager abbandonati a se stessi, senza cure, né acqua, né cibo, al freddo, decimati dal tifo, dalla difterite, dalla dissenteria. Levi è tra i pochissimi che riescono a sopravvivere e il romanzo si conclude con la cronaca di quei terribili giorni, dal 19 al 27 gennaio 1945.
Quando arrivano i Russi, lo spettacolo che si offre ai loro occhi è quello terrificante dei cadaveri che si ammucchiano sulla neve e dei pochi superstiti che si aggirano come spettri tra le rovine del campo. Uno spettacolo che suggella in modo emblematico l’opera di sterminio programmatico messa in atto dal nazismo.
Il romanzo, come si è detto, nasce dall’urgenza di rendere partecipi gli altri delle esperienze vissute, ma mantiene una certa imparzialità nel giudicare la Germania e il suo popolo. Non accade mai di imbatterci in espressioni di viscerale risentimento o di incontrollato furore. Il suo giudizio si mantiene sempre con lucidità su un tono di condanna morale.
Il libro è però caratterizzato dalla concitazione di un messaggio indifferibile e l’impianto narrativo segue l’incalzare tumultuoso con cui i ricordi si affollano alla memoria. Ma questi, che potrebbero essere visti come difetti, conferiscono invece all’opera il pregio dell’immediatezza, quel carattere di appassionata confessione, di concitato abbandono al flusso dei ricordi.