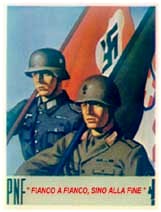
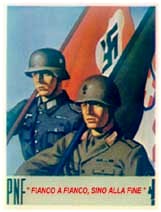
La suggestiva formula dell'"alleato occupato",
proposta da Lutz Klinkhammer come chiave di lettura dell'esperienza
dell'occupazione dell'Italia da parte della Wehrmacht in un
importante libro [L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945
, Bollati Boringhieri 1993] uscito a trent'anni esatti di distanza
dalla pubblicazione del primo studio complessivo sull'argomento
condotto sulle fonti tedesche dal sottoscritto
[L'Amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945,
1963], sintetizza bene il doppio volto della situazione nella quale
venne a trovarsi l'Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del
1943. Tagliato in due dalle forze anglo-americane che avanzavano
lentamente risalendo la penisola dalla punta meridionale dello
stivale e dal golfo di Salerno, la parte centro-settentrionale del
nostro paese fu occupata quasi senza colpo ferire dalle forze
tedesche. Il 12 settembre, la liberazione di Mussolini
dall'improvvisato confino nel gruppo del Gran Sasso, ad opera di una
operazione più spettacolare che spericolata di paracadutisti
tedeschi, segnò il successo propagandistico del quale i tedeschi
avevano bisogno per coprire l'occupazione dell'Italia sotto la
parvenza della continuazione dell'alleanza tra fascisti e
nazisti.
In effetti, la sorte dell'Italia fu racchiusa tutta
nell'ambivalenza di una condizione stretta tra le esigenze e la
realtà dell'occupazione e la necessità politico-propagandistica
della sopravvivenza di una alleanza, il cui riconoscimento effettivo
si scontrava con condizioni di fatto che oggettivamente tendevano a
negarlo. Al di là dell'interesse personale di Hitler nei confronti
della persona, più che del ruolo, di Mussolini, la Germania era
interessata a tenere l'Italia per arrestare l'avanzata
anglo-americana sulle posizioni più lontane possibili dal confine
meridionale del Reich. Quindi, non era in primo luogo il salvataggio
dell'alleanza che aveva suggerito di non abbandonare il territorio
italiano e di farne viceversa teatro di una guerra combattuta
chilometro per chilometro, lungo la dispendiosa dorsale appenninica
destinata a rendere particolarmente dura la condotta delle
operazioni ai due contrapposti schieramenti operativi, oltre che
alle popolazioni investite dai movimenti del fronte.
La seconda
motivazione forte dal punto di vista tedesco a favore del tentativo
di conservare il controllo del territorio italiano era la
possibilità di sfruttarne il potenziale economico, industriale ed
agricolo, tanto più in una fase di progressivo abbandono dei
territori occupati nell'est europeo che avevano costituito un'area
di indiscriminato saccheggio, e soprattutto la manodopera italiana
che veniva liberata da obblighi militari. Non era un mistero - e
bene lo rivelerà tra l'altro il Diario di Goebbels - che l'ipotesi
della secessione dell'Italia dal conflitto già nei mesi precedenti
era considerata, da una parte almeno dei capi nazisti, quasi come la
liberazione da un peso morto e la prospettiva, finalmente, di potere
incondizionatamente utilizzare gli uomini italiani come lavoratori
per lo sforzo bellico del Terzo Reich. La cattura dopo l'8 settembre
di quasi 700 mila soldati italiani non fu una semplice ritorsione
contro il "tradimento" dell'alleato, fu anche un piano premeditato
per il trasporto coatto in Germania di una manodopera che non
sarebbe "stato possibile procurare con metodi diversi".
Le
vicende dell'arruolamento e del reclutamento di lavoratori dopo l'8
settembre, con il fallimento pressoché totale del tentativo di
indurre da due a tre milioni di italiani a recarsi a lavorare
nell'apparato della produzione bellica nazista, confermarono che
l'unico mezzo per potere ricavare manodopera forzata erano le razzie
indiscriminate. Del resto, prima ancora che entrassero in funzione
le "agenzie" specializzate per il reclutamento di manodopera, a
cominciare da quella incaricata da Hitler di rastrellare braccia da
tutta Europa per la guerra del Reich affidata al "Gauleiter"
Sauckel, sin dal 16 settembre del 1943 il feldmaresciallo Keitel,
capo del comando supremo della Wehrmacht, aveva emanato un ordine
draconiano per il trasferimento coatto con tutti i mezzi possibili,
nessuno escluso, del maggior numero possibile di uomini abili al
lavoro dalle aree minacciate dall'occupazione anglo-americana alla
zona sotto controllo dei tedeschi. L'ordine di Keitel indicava un
obiettivo ma anche un metodo, che in linea di massima non fu
smentito neppure dopo la creazione formale della Repubblica sociale
neo-fascista.
E qui veniamo alle motivazioni politiche che
impedivano alla Germania di abbandonare l'Italia al suo destino. La
Germania aveva bisogno dell'Italia non soltanto come terreno di
sfruttamento economico, ma anche come emblema e simbolo della
sopravvivenza dell'alleanza. Hitler doveva dimostrare ai popoli
dell'Europa, nel momento in cui faceva appello alla difesa della
"fortezza Europa" come copertura per la difesa della Germania e
degli interessi esclusivamente tedeschi, che continuava a sussistere
lo schieramento dell'Asse e del Patto tripartito, addirittura
rafforzato e non indebolito dal "tradimento" di Badoglio [la
propaganda tedesca, ricacciando tutte le responsabilità su Badoglio,
cercava di dare verso l'esterno una versione riduttiva dell'uscita
dell'Italia dalla guerra], grazie alla fedeltà all'alleanza del
nucleo duro dei fascisti repubblicani. Ma una motivazione ancora più
forte consisteva nel monito che contemporaneamente e implicitamente
veniva lanciato all'indirizzo degli altri alleati satelliti della
Germania [in particolare Ungheria e Romania] che avessero voluto
seguire l'esempio dell'Italia. Il messaggio era evidente: nessuno
sarebbe sfuggito alla sorte di dover subire la reazione tedesca e di
essere declassato al rango di territorio occupato. Nel marzo del
1944 infatti l'Ungheria avrebbe subito una occupazione ancora più
dura di quella che fu riservata all'Italia.
A questo punto, anche
a prescindere dalle ragioni che imponevano in ogni paese occupato la
necessità di ricercare collaboratori nel contesto locale, per
esigenze funzionali e per opportunità politico-propagandistiche [la
ricerca di un consenso, per limitato che fosse], a maggior ragione
necessaria diventava la collaborazione in una situazione come quella
italiana in cui si voleva salvare almeno la facciata della
continuità dell'alleanza.
La problematica della Repubblica
sociale italiana è così indissociabilmente legata a quella
dell'occupazione tedesca.
La Rsi svolse in questa fase un duplice
ruolo: quello del collaborazionismo con gli occupanti e al tempo
stesso quello dell'antagonista delle forze della Resistenza
[appunto, le parti in causa della "guerra civile", in quanto
protagonista del tentativo di risuscitare il fascismo, anche
attraverso una sorta di autocritica rispetto al fascismo del
ventennio ma sempre all'ombra delle armi tedesche. La presenza della
Wehrmacht fu il presupposto di questo tentativo di reviviscenza
neofascista: quale che sia il ruolo che si vuole attribuire alla
Rsi, semplice creazione dei tedeschi o espressione autonoma di una
volontà di collaborare con i tedeschi nei limiti indicati, è
all'interno di queste coordinate e di questo contesto che va situata
la sua collocazione.
Mussolini dovette avere ben presto la
sensazione di essere costretto a recitare la parte di un Quisling o
di un "Gauleiter", ma era poco più che un ostaggio nelle mani di
Hitler. Non gli riuscì neppure il tentativo di salvare la faccia del
nuovo fascismo repubblicano. Animato a parole da volontà di
pacificazione, nei fatti dovette cedere al volto neosquadristico e
truce del fascismo repubblicano. La fucilazione di Ciano e degli
altri gerarchi che gli avevano votato contro nella riunione del Gran
Consiglio segnò il prevalere della ragione di stato e dello spirito
di vendetta su ogni altro comportamento.
Anche questo, con la
crescente brutalizzazione nei metodi, con l'intimidazione della
popolazione o con la ferocia dei rastrellamenti antipartigiani, un
aspetto di quella nazificazione del fascismo di Salò che è una delle
cifre per leggere la realtà di quei terribili venti
mesi.
Nell'Italia occupata le autorità tedesche si sovrapponevano
sistematicamente alle infrastrutture italiane. Gli organi
dell'occupazione avevano bisogno della collaborazione, ma non
intendevano pagare che il prezzo minore possibile. L'autonomia che
esse erano disposte a lasciare alle forze collaborazioniste era in
funzione delle loro esigenze, non di quelle dei collaboratori. La
misura dell'autonomia andava perciò rapportata a ciò che la potenza
occupante reputava funzionale ai suoi obiettivi; perciò, nel momento
in cui una autonomia troppo larga minacciava di mettere in
discussione la subalternità dell'occupato la potenza dominante
restringeva l'area delle concessioni. In questi termini la Germania
gestì le modalità della collaborazione in tutta l'Europa occupata.
Non c'era ragione perché, con pochi adattamenti, lo stesso modulo
non dovesse funzionare anche in Italia. L'ultima parola non spettava
a Mussolini o ai suoi collaboratori ma all'ambasciatore Rahn, il
vero capo del governo civile della Rsi, al gen. Wolff, il capo della
polizia e delle SS, al gen. Leyers, il capo della struttura preposta
allo sfruttamento dell'economia italiana, ai comandanti della
Wehrmacht.
Le poche concessioni che il Reich fece a Mussolini
furono di carattere prevalentemente formale. Quando Mussolini si
lamentò presso Hitler della nomina del gen.Toussaint a comandante
miliare in Italia, l'Okw lo accontentò modificandone l'incarico
formale in quello di Generale plenipotenziario della Wehrmacht
tedesca presso il governo fascista italiano. Ma la funzione degli
organi tedeschi come "amministrazione di controllo nei confronti del
governo italiano indipendente" [secondo l'espressione di un
documento tedesco dell'epoca] non risultò in nulla modificata. La
sovranità della Rsi non fu limitata soltanto nell'esercizio di un
potere, che generalmente era un potere esecutivo per conto dei
tedeschi o al più un potere da loro delegato: lo fu anche dal punto
di vista territoriale, nel senso che fu sottratta alla Rsi la
possibilità di esercitare un potere anche solo delegato in numerose
provincie dell'ex regno d'Italia: la creazione delle speciali Zone
d'operazione delle Prealpi [province di Bolzano, Trento e Belluno] e
del Litorale Adriatico [la vecchia Venezia Giulia, la provincia di
Udine e la nuova provincia di Lubiana], gestite da Alti commissari
tedeschi alle dirette dipendenze di Hitler, preluse all'annessione
intanto di fatto e in prospettiva di diritto di questi territori al
Grande Reich. Neppure le rivendicazioni di Mussolini in questa
direzione trovarono alcuna udienza. Allegando le inderogabili
necessità militari, che esigevano il controllo di quelle zone
essenziali per il transito e il collegamento delle forze militari
tedesche, Hitler ribattè che nulla era possibile modificare del loro
statuto. A lunga scadenza, quelle aree erano destinate a far parte
direttamente del Grande Reich.
Ma neppure sotto altri profili la
Rsi riuscì a darsi gli strumenti operativi che sottolineassero la
propria autonomia. Il caso più rilevante fu certo il tentativo di
tornare in capo con una propria forza armata, che fu frustrato sia
dai militari catturati dai tedeschi l'8 settembre che nei campi di
prigionia in Germania rifiutarono in massa di entrare nell'esercito
con il simbolo del gladio [un'altra non casuale coincidenza!], sia
dagli stessi tedeschi. Non fidandosi di ridare le armi a soldati
italiani, i tedeschi imposero drastici limiti quantitativi alle
unità della Rsi, sicché dalle 25 divisioni in origine richieste da
Graziani si arrivò di fatto alle quattro divisioni accordate, da
addestrare per giunta in Germania e da destinare prevalentemente
alla lotta antipartigiana. Maggiore autonomia i fascisti di Salò
ebbero nell'allestire la Guardia Nazionale Repubblicana [nuova
versione della vecchia milizia fascista] è nei reparti speciali, che
si distinsero in azioni repressive e in rastrellamenti di
partigiani, di lavoratori, di ebrei.
Il fascismo della Rsi fu
umiliato anche negli aspetti con i quali tentava di darsi una
fisionomia originale e di esprimere con una accentuata polemica
antiborghese, meramente parolaia e demagogica, l'autocritica
rispetto al fascismo del ventennio. Il caso più clamoroso di
conflitto con le autorità tedesche fu rappresentato dai progetti di
socializzazione dell'industria proclamati nel gennaio del 1944, allo
scopo fra l'altro di convogliare verso il fascismo di Salò il
consenso delle masse di lavoratori, e segnatamente degli operai,
soprattutto del triangolo industriale. L'opposizione delle autorità
tedesche a questi progetti, nel timore che riforme per quanto
superficiali avviate nel mezzo della congiuntura bellica potessero
compromettere lo sforzo di trarre il massimo profitto possibile
dallo sfruttamento dell'apparto produttivo italiano, fu così
esplicita che gli stessi industriali italiani preferirono di fatto
trattare direttamente con i tedeschi e ricorrere alla loro
protezione contro gli interventi minacciati dalla Rsi Al di là della
volontà di evitare ogni misura che potesse turbare il funzionamento
delle fabbricazioni di interesse bellico, già soggette a numerosi
fattori di rallentamento [non soltanto lo scarso e irregolare
rifornimento di materie prime, ma anche il sabotaggio e le ripetute
astensioni dal lavoro nel quadro di un movimento quasi ininterrotto
di agitazioni], le autorità tedesche non manifestavano alcun
interesse al rafforzamento del partito fascista repubblicano e della
sua immagine. come in altri contesti del sistema di occupazione,
esse erano interessate ad assicurarsi ai fini della collaborazione
la continuità di un apparato amministrativo in loco, piuttosto che
la rinascita di una forza politica specificamente fascista. Oltre
tutto, la sorte del fascismo, dissoltosi il 25 luglio come neve al
sole, era stato oggetto di sprezzanti e feroci commenti
nell'entourage nazista; Hitler e i suoi non cessarono di
rimproverare a Mussolini la corruzione che aveva caratterizzato la
gestione del regime fascista, ma soprattutto il dualismo di potere
che aveva consentito la sopravvivenze e la coesistenza con il regime
della monarchia e della stessa Chiesa cattolica. Tuttavia, il
ritorno alle origini del fascismo di Salò, con il suo
repubblicanesimo dell'ultima ora [a spese fra l'altro del povero
Mazzini, finito anche sui francobolli della Rsi] nel quadro di quel
processo di nazificazione al quale alludevamo prima, non poteva
ingannare neppure i tedeschi. Nessuna comprensione venne da parte
loro nei confronti degli sforzi di ricostruire un nuovo partito
fascista. I rapporti locali delle autorità tedesche sono pieni di
giudizi liquidatori nei confronti del nuovo fascismo repubblicano.
Lo stato d'animo dei tedeschi, che non di rado giudicarono il nuovo
partito fascista addirittura un fattore di disturbo e di intralcio
dello stesso ordine pubblico, fu espresso con la massima drasticità
in un rapporto della propaganda tedesca dell'inizio di novembre del
1943, che definiva l'esperienza del fascismo di Salò come null'altro
che "vino vecchio in un otre nuovo". Una formulazione tanto
pittoresca quanto demolitoria.
Dove poi la collusione con i
tedeschi si rivelò, si può dire, totale fu nella caccia agli ebrei.
Sin dal Manifesto di Verona del fascismo repubblicano del 9 novembre
del 1943 la caccia agli ebrei era entrata in una fase di ulteriore
accelerazione [al punto 7 si diceva: "Gli appartenenti alla razza
ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a
nazionalità nemica"]. L'invio degli ebrei in campo di concentramento
ordinata dal ministro degli interni di Salò agevolò la loro
deportazione da parte dei tedeschi, che già da soli avevano iniziato
il 16 ottobre, con la deportazione degli ebrei romani, l'attuazione
anche in Italia della "soluzione finale".
Klinkhammer ha
documentato come nella primavera del 1944 gli ordini repressivi
emanati da Kesselring e dai comandi tedeschi per fare fonte alla
crescente consistenza della minaccia partigiana preparassero il
terreno "per la radicalizzazione della lotta contro la guerriglia".
E ciò non significava soltanto repressione antipartigiana ma anche
intensificazione delle rappresaglie contro i civili, in altre parole
la politica delle stragi che insanguinò la marcia della Wehrmacht
che risaliva lentamente l'Appennino sotto la pressione alleata. Un
terreno, anche questo, nel quale le forze tedesche poterono contare
sulla collaborazione delle unità di Salò. Del resto, la consonanza
della Rsi con i tedeschi era nei fatti. Il 28 marzo 1944, Il
Messaggero diretto da Bruno Spampanato aveva definito la strage
delle Fosse Ardeatine un atto di "esemplare giustizia tedesca".