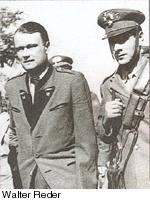
La strage di Marzabotto
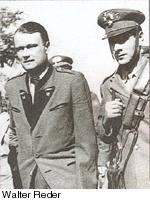
La strage di Marzabotto del 29 settembre 1944 fu la
tragica tappa finale di una «marcia della morte» che era iniziata in Versilia. L'esercito alleato indugiava davanti alla Linea Gotica e
il maresciallo Albert Kesserling, per proteggersi dall'«incubo» dei
partigiani, aveva ordinato di fare «terra bruciata» alle sue spalle.
Kesserling fu il mandante di una strage che nessun'altra superò
per dimensioni e per ferocia e che assunse simbolicamente il nome di
Marzabotto anche se i paesi colpiti furono molti di più.
L'esecutore si chiamava Walter Reder. Era un maggiore delle SS
soprannominato «il monco» perché aveva lasciato l'avambraccio
sinistro a Charkov, sul fronte orientale. Kesserling lo aveva scelto
perché considerato uno «specialista» in materia.
Al comando del
16° Panzergrenadier «Reichsfuhrer», il «monco» iniziò il 12 agosto
una marcia che lo porterà dalla Versilia alla Lunigiana e al
Bolognese lasciando dietro di sé una scia insanguinata di tremila
corpi straziati: uomini, donne, vecchi e bambini.
In Lunigiana
si erano uniti alle SS anche elementi delle Brigate nere di Carrara
e, con l'aiuto dei collaborazionisti in camicia nera, Reder continuò
a seminare morte. Gragnola, Monzone, Santa Lucia, Vinca: fu un
susseguirsi di stragi immotivate. Nella zona non c'erano partigiani:
lo dirà anche la sentenza di condanna di Reder: «Non c'erano
combattenti. Nei dirupi intorno al paese c'era soltanto povera gente
terrorizzata...».
A fine settembre il «monco» si spinse in
Emilia ai piedi del monte Sole dove si trovava la brigata partigiana
«Stella Rossa». Per tre giorni, a Marzabotto, Grizzana e Vado di
Monzuno, Reder compì la più tremenda delle sue rappresaglie. In
località Caviglia i nazisti irruppero nella chiesa dove don Ubaldo
Marchioni aveva radunato i fedeli per recitare il rosario. Furono
tutti sterminati a colpi di mitraglia e bombe a mano.
Nella
frazione di Castellano fu uccisa una donna coi suoi sette figli, a
Tagliadazza furono fucilati undici donne e otto bambini, a Caprara
vennero rastrellati e uccisi 108 abitanti compresa l'intera famiglia
di Antonio Tonelli (15 componenti di cui 10 bambini).
A
Marzabotto furono anche distrutti 800 appartamenti, una cartiera, un
risificio, quindici strade, sette ponti, cinque scuole, undici
cimiteri, nove chiese e cinque oratori. Infine, la morte nascosta:
prima di andarsene Reder fece disseminare il territorio di mine che
continuarono a uccidere fino al 1966 altre 55 persone.
Complessivamente, le vittime di Marzabotto, Grizzano e Vado di
Monzuno furono 1.830. Fra i caduti, 95 avevano meno di sedici anni,
110 ne avevano meno di dieci, 22 meno di due anni, 8 di un anno e
quindici meno di un anno. Il più giovane si chiamava Walter Cardi:
era nato da due settimane.

1944, i funerali delle vittime
Dopo la liberazione Reder, che era riuscito a raggiungere la Baviera, fu catturato dagli americani. Estradato in Italia fu processato dal Tribunale militare di Bologna nel 1951 e condannato all'ergastolo. Dopo molti anni trascorsi nel penitenziario di Gaeta fu graziato per intercessione del governo austriaco. Morì pochi anni dopo in Austria senza mai essere sfiorato dall'ombra del rimorso.
(in il Resto del Carlino, 12 aprile 2002)
I sopravvissuti
A Marzabotto gli unici sopravvissuti furono due
bambini, Fernando Piretti, di otto anni, e Paolo Rossi di sei, e una
donna, Antonietta Benni, maestra d'asilo delle Orsoline. Per 33 ore
finse di essere stata abbattuta anche lei e quando finalmente potè
alzarsi, commentò ad alta voce: «Tutti morti, la mia mamma, la mia
zia, la mia nonna Rosina, la mia nonna Giovanna, il mio
fratellino... Tutti morti». Anche a Marzabotto alcune SS parlavano
un italiano perfetto: erano italiani.
I
collaborazionisti italiani
Per i fatti di Marzabotto ci fu anche una coda
processuale italiana. Prima della condanna del maggiore Reder, nel
1946, la corte d'assise di Brescia aveva giudicato Lorenzo Mingardi
e Giovanni Quadri, due repubblichini (il primo, reggente del Fascio
di Marzabotto, nonché commissario prefettizio durante la
carneficina), per collaborazione, omicidio, incendio e devastazione.
Mingardi ebbe la pena di morte, poi trasformata in ergastolo. Il
secondo, 30 anni, poi ridotti a dieci anni e otto mesi. Tutti e due
furono successivamente liberati per amnistia.