Nel 1895 dopo il matrimonio di Ida, Pascoli prese in affitto una casa a Castelvecchio, nella campagna lucchese. Qui con l'altra sorella, concretizza la costruzione del suo nido, trascorrendo lunghi periodi in campagna lontano dalla vita cittadina che detestava, e ricreando un Eden di serenità e pace, di sentimenti semplici e puri. Infatti proprio i caratteri della sua poesia rispecchiano in modo significativo il tentativo di creare un cantuccio di tranquillità in cui, attraverso l'attenzione per le cose semplici e umili, dare alle piccole cose una dignità e un valore non minore di quelle auliche. Queste tematiche sono certamente coincidenti e sovrapponibili con quelle enunciate nel periodo romantico da Wordsworth. Infatti nella Prefazione alle ballate liriche, sono evidenti le analogie con la poetica di Pascoli: i romantici sceglievano come campo di indagine della loro poesia la vita umile e rustica, poiché affermava che le passioni e i sentimenti trovano il terreno giusto su cui maturare e trasmettere il loro messaggio nel modo più spontaneo possibile. Certamente questi caratteri distintivi della poetica romantica non possono essere attribuiti completamente al poeta, poiché il Pascoli rimane comunque ancorato alla poetica decadente. Infatti il constatare questi valori tipici del Romanticismo rappresenta solamente il punto di partenza del suo pensiero, che si contraddistingue per una insoddisfazione lamentosa del presente e per sentimenti di angoscia e turbamento decadenti.
Questo geloso contenitore, guscio chiuso ed esclusivo, si allarga
agevolmente ad inglobare l'intera nazione; i valori contenuti all'interno
del nucleo famigliare si dilata identificandosi con la stessa nazione italiana.
Questa è la radice del nazionalismo pascoliano. Egli sente con grande angoscia
il dramma dell'emigrazione: l'italiano è costretto a lasciare il suolo della
patria è come colui che, attraverso la sua esperienza personale, viene strappato
dal nido, dove sono radicate le origini del suo essere. " Non per nulla ad
un certo punto, l'umanitarismo pascoliano si preciserà in una forma di nazionalismo
rigido e chiuso, esclusivo, allargando alle proporzioni della nazione la visione
del rapporto sociale come affetto del sangue, voce delle viscere, e gelosamente
difendendo il "nido" costituito dalla nazione allo stesso modo che l'eguale
cerchio chiuso e segreto della famiglia […]". Questa tragedia dell'emigrazione
induce Pascoli a far proprio un concetto diffuso del nazionalismo italiano
del primo novecento: esistono nazioni ricche e potenti, capitaliste, e nazioni
proletarie, come l'Italia, povere, deboli ed oppresse. Ebbene, il Pascoli
arriva ad ammettere la legittimità che queste ultime nazioni cerchino la soddisfazione
dei loro bisogni anche attraverso le guerre per le conquiste coloniali; in
modo da fornire la terra e lavoro ai suoi figli più deboli. In tal caso si
tratta di guerra di difesa e non di offesa e pertanto sacrosanta. Sulla base
di queste considerazioni, Pascoli appoggia e celebra la guerra
di Libia, poiché rappresenta un momento di riscatto della nazione italiana.
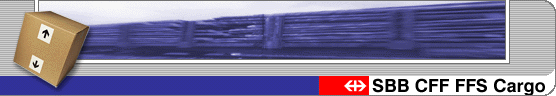

|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||